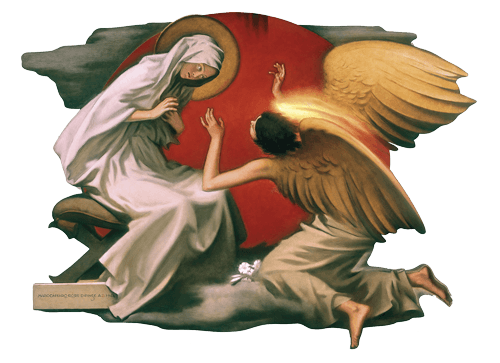Abbiamo un’altra pagina che ci aiuta a capire meglio quanto lo Spirito sia importante per diventare creatura nuova in Cristo (1 Cor 2, 12-16).
_Ora, noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo, ma lo Spirito di Dio per conoscere ciò che Dio ci ha donato 13 Di queste cose noi parliamo, con parole non suggerite dalla sapienza umana, bensì insegnate dallo Spirito, esprimendo cose spirituali in termini spirituali. 14 Ma l’uomo lasciato alle sue forze non comprende le cose dello Spirito di Dio: esse sono follia per lui e non è capace di intenderle, perché di esse si può giudicare per mezzo dello Spirito. 15 L’uomo mosso dallo Spirito, invece, giudica ogni cosa, senza poter essere giudicato da nessuno. 16 Infatti chi mai ha conosciuto il pensiero del Signore in modo da poterlo consigliare? Ora, noi abbiamo il pensiero di Cristo”.
Noi abbiamo la sapienza dello Spirito Santo, che ci dice e ci unisce a ciò che “Dio ci ha donato”. Che cosa ci ha dato in dono? Il Figlio crocifisso, che è “il segreto di Dio” che egli “ha prestabilito prima dei secoli per la nostra gloria”. Segreto che nessuno “dei dominatori di questo mondo ha conosciuto”. Non è con l’intelligenza della terra che si capisce il disegno di Dio sul mondo. E il crocifisso rimanda all’agape, mentre il mondo vive sull’idea del potere, dell’affermazione di sé e del possedere. Ora l’agape è la vita stessa del Dio trinitario: non cela si può dare, la si può solo accogliere. E’ essa che ci rende “nuovi”. Ci siamo imbevuti del linguaggio del mondo. Ci vuole un linguaggio non suggerito dalla sapienza umana. “Io, fratelli, sinora non ho potuto parlare a voi come a esseri spirituali, ma carnali, come a neonati in Cristo. 2 Vi ho dato da bere latte, non cibo solido, perché non ne eravate ancora capaci. E neanche ora lo siete, 3 perché siete ancora carnali. Dal momento che vi sono tra voi invidia e discordia, non siete forse carnali e non vi comportate in maniera umana?”
Si può sulla vita dell’uomo vecchio costruire una cultura cristiana, con valori cristiani, con precetti cristiani, con atteggiamenti cristiani, con idee cristiane. Così però l’organismo spirituale non funziona. E’ un modo di vivere esposto continuamente alla frustrazione dell’incoerenza e dello scetticismo. Sembra che funzioni quasi tutto, tranne che nelle relazioni interpersonali. Qui non si può fingere. Le relazioni hanno la loro radice nel Dio trinitario e non nell’uomo. Allora se c’è difficoltà a “vivere tra noi” è perché il baricentro della nostra coscienza è spostato sulla sfera psicosomatica: è tutto dominato dai sentimenti istintivi e dalle pulsioni emotive. Impera la reattività delle opinioni, dell’interesse, del comodo e del piacevole. E lo Spirito si è allontanato. Lo si vede dall’invidia e dalla discordia che questo modo di vivere genera nelle comunità cristiane. Non c’è più accoglienza reciproca, ma sete di primeggiare. Quando è così si è nella logica dell’uomo vecchio.
Questo spostamento dalla realtà divina in noi alla sfera psicosomatica necessariamente produce moralismo: che cosa può capire l’uomo vecchio (senza lo Spirito) dell’insegnamento cristiano se non fermarsi a ciò che “si deve fare”. Conosciuta la teoria, pensiamo che a quel punto basta fare ciò che si è capito, come se fosse automatico “il passaggio dal pensiero al fare”. Questo è il modo di funzionare di qualsiasi ideologia. Nelle forme ideologiche (anche religiose) uno afferma: questa è l’idea, adesso la faccio, come se l’uomo senza lo Spirito fosse capace di realizzarla. Produce al massimo spezzoni di vita. Ma nella realtà non è così che funziona. La debolezza dell’uomo non è nelle idee, ma nella volontà. E la volontà ha bisogno di essere trasformata nell’energia dello Spirito che la fa aderire in una vita nuova a Cristo, cambiando la coscienza di sé: non più in chiave autonoma, ma relazionale con Cristo nello Spirito.
Questa modalità ideologica e razionalista ha stancato così tanto l’Europa, che oggi questa preferisce “essere qualsiasi cosa”, ma non essere cristiana. E noi credenti quando apriamo la bocca parliamo di valori e di etica, invece di testimoniare la vita dello spirito che si è ricevuto da Cristo. La gente europea è stanca dell’ideologizzazione della nostra fede e del moralismo.
La storia di ogni uomo è rivelazione del rapporto che Dio stabilisce con ciascuno di noi.
L’azione propria dello Spirito è di introdurci a costruire una “storia con Dio”. Quando ci si sente dentro ad una relazione d’affetto e di tenerezza con il Dio della vita, si guarda la storia con occhi diversi. Avere una storia con Dio, una storia reale non ossessiva, dove dentro ci sta di tutto: la fatica, il lavoro, la gioia di un risultato. E’ questo che ci è venuto a mancare. L’abbiamo annegata dentro ai nostri pensieri e alle nostre regole. Dobbiamo re-imparare dalla storia di Gesù con i suoi. La normalità della fede è questo rapporto affettivo che abbraccia tutto. Uno che ha una storia reale con Dio lo si vede anche solo dagli occhi. Si vede dalla naturalezza con cui vive in compagnia. Lo si vede dalla gentilezza dello sguardo abitato dalla certezza della sua presenza. Stare con Dio, ecco tutto: “sia che vegliamo sia che dormiamo, viviamo insieme con lui” (1 Ts 5, 10); “sia che mangiate, sia che beviate sia che facciate qualsiasi altra cosa, fate tutto per la gloria di Dio” (1Cor 10,31). Quando uno è stato nelle vicinanze di Dio così, allora basta un guizzo, un’occhiata, un lampo di affettuosa ironia verso il mondo, gli altri e se stessi, che tutto è visto con benevolenza senza autopunirsi e si riesce a guardare gli altri senza sentirli fastidiosi. La fede si svolge così. E’ il senso del tutto dentro all’istante. E’ il fremito dolce di una presenza dentro al dolore e alla fatica delle rughe di un vecchio, come dentro alla letizia di un viso gioioso di bambino che ti sorride. Una storia con Dio è la storia di una leggerezza che tramuta in bellezza le cose più dure e pesanti, dove persino la mediocrità in cui abbiamo ridotto il nostro cristianesimo non ci scandalizza più, ma diventa lo spazio per immergerci ancora di più nella misericordia di Gesù. Le cose più vere di cui viviamo possono sopravvivere solo mettendole lì, nella vicinanza ospitale di Dio.
Uscire da una religiosità vuota e entrare nel rapporto con il Dio vivo
L’amore di Dio è come un raggio di luce che attraverso la debolezza (il fango) dell’uomo, senza sporcarsi, ma trasfigurandolo. Come il vino di Cana di Galilea, dove la fede ha trasformato l’acqua delle giare in vino gustoso. “Le sei giare di pietra e vuote – interpretano i Padri – è una religione ormai decaduta a legge, svuotata a religione moralistica, che si è prosciugata, e non serve più per la purificazione, perché non hanno più nulla dentro”. In quelle nozze che prefigurano il rapporto gioioso con Dio, l’amato, le nozze dell’Agnello – non c’è più vino. Il vino nei libri sapienziali è il senso della vita: “Che vita è quella dove manca il vino? Fin dall’inizio è stato creato per la gioia degli uomini” (Sir 31,27). Se viene a mancare il sapore, il gusto della vita, per che cosa si sposano? Una religione che finisce in un moralismo di cose da fare, di impegni da assolvere, di doveri senza anima: non serve più. All’inizio del suo Vangelo Giovanni introduce una nuova alleanza tra l’uomo e Dio basato sull’amore, su una reciprocità che include senza violare la libertà, un incontro di due desideri che si cercano e si attraggono (la samaritana).
Quando il Cristo muore “emise lo spirito” sulla Chiesa nascente, che ha raccolto questo respiro e comincia a vivere la vita filiale. Si apre il costato e da questa fessura fuoriesce l’umanità nuova: è dalla ferita che siamo generati. Figli si diventa non per conquista, ma per dono gratuito quando lo si accoglie: “A quanti lo accolgono ha dato il potere di diventare figli di Dio” (Gv1, 12). Paolo fa eco a queste espressioni: “Tutti coloro che sono guidati dallo Spirito di Dio, costoro sono figli di Dio” (Rom 8, 14). Non più con lo sforzo, ma con un’apertura accogliente. Si entra nella vita divina, allo stesso modo di come si nasce: non per un merito, nè per uno sforzo, ma per una grazia e per dono d’amore.
Il giovane ricco e il buon pastore (Mc 10, 17 e Gv 10, 14…)
Una figura della religione scaduta la si ritrova in Mc 10,17 in quel giovane che “corre” verso Cristo e “si getta in ginocchio” ai suoi piedi con una domanda. In Medio oriente non si corre, si mantiene la maestosità del passo calmo, a meno che non si sia oppressi. Marco invece usa questo verbo solo due volte. E’ dunque un verbo raro. Ed è strano, perché quel giovane era ricco e molto osservante, aveva cioè soldi e dalla sua parte la religione che osservava alla lettera, però non era felice. Aveva paura della morte, cercava ciò che lo facesse vivere eternamente, cercava la vita eterna “Che cosa devo fare per avere la vita eterna?” Mc 10, 17.
Si può ridurre la religione a prestazione religiosa per conquistarsi una ricompensa e sfuggire al castigo divino. Ma proprio da questo Cristo è venuto a liberarci. La vita eterna sta invece nel rapporto filiale verso il Padre che lo Spirito di Cristo genera in noi: “Lascia tutto – gli dice Gesù – poi vieni e seguimi”, entra cioè in rapporto vitale con me, poiché “questa è la vita eterna: che conoscano te, l’unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo” (Gv 17, 3). Che conoscano: significa che entrino in un rapporto affettuoso e vitale con “Dio”, cioè il Padre e il Figlio.
In Giovanni, Gesù mostra il cuore della religiosità che sta nel rapporto tra Lui, pastore affascinante e attraente e le pecore: “Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, così come il Padre conosce me e io conosco il Padre, e do la mia vita per le pecore”. E che cosa fa questo pastore: “Le conduce fuori e quando le ha spinte fuori tutte, cammina davanti a loro e le pecore lo ascoltano, perché conoscono la sua voce”. Ma l’evangelista come chiama il “recinto” da cui le pecore vengono tratte fuori? Gv usa il termine aulḗn, che è prima di tutto l’atrio del tempio. E qui si ricollega all’inizio della vita pubblica, quando Gesù caccia fuori dal tempio “tutti con le pecore e i buoi, getta a terra il denaro dei cambiavalute e ne rovescia i banchi”. Con la sua presenza inizia un nuovo tipo di religiosità, che passa attraverso la distruzione del tempio antico e la sua ricostruzione in tre giorni, alludendo al sacrificio del “suo corpo”.
Il cammino pasquale è posto fin dall’inizio della vita pubblica, perché è il percorso che ogni credente deve fare. Ma è anche l’inizio di una nuova religiosità, che supera quella degli scribi e farisei: la religiosità dell’incontro e del rapporto. Una religiosità che genera libertà interiore.
Riprendendo, in un secondo momento, l’immagine del pastore, Giovanni la trasforma con quella della porta: “Io sono la porta: se uno entra attraverso di me, sarà salvato; entrerà e uscirà e troverà pascolo. …io sono venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza” (Gv 10, 9-10). La via della libertà sta nel lasciarsi attraversare dall’esperienza con Gesù. La porta è il luogo dell’incontro, dove si supera la separazione tra esterno ed interno, tra fuori e dentro. Il lavorio dello Spirito è quello di creare legami e liberare dalle esteriorità. Quando si giunge a questo si è di fronte alla creatura rigenerata che può diventare testimone del suo Signore.
P. Antonello Erminio
Ascolta audio della prima meditazione
Ascolta audio della seconda meditazione