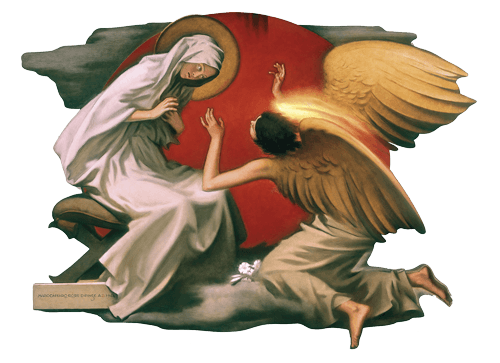Gesù risorto dona lo Spirito.
Nella vita spirituale si rimane sovente oppressi dalla fatica e allora ci si immerge nell’esteriorità. E’ facile perdere il contatto con il Mistero con cui Dio si dona a noi. L’uomo vive grazie alle relazioni che maggiormente lo sostengono e lo animano. Anche la vita interiore e spirituale vive delle relazioni di cui si nutre l’anima. E dire “vita spirituale” non vuol dire semplicemente “stare presso se stessi con attenzione e coscienza vigile”, ma vivere la vita nello Spirito, ossia nel movimento che sgorga da una relazione che riempie l’anima. Il linguaggio di questa relazione è la preghiera che è come il balbettio di un bimbo che è riconosciuto immediatamente dalla mamma. E’ come la lingua madre, che ci viene misteriosamente insegnata nel contatto con lo Spirito Santo che inabita in noi, poiché è Lui che “interpreta le attese inquiete del nostro cuore, e nemmeno sa che cosa chiedere” (Rom 8, 26).
Il contatto con Gesù è la relazione che dà volto al cristiano.
Questa relazione con lo Spirito Santo ci è stata rivelata da Gesù. Egli ci ha detto: “E’ bene per voi che Io me ne vada, perché se non me ne vado non verrà a voi il Paralitico, lo Spirito che è l’amore che li lega reciprocamente (Gv 14,16). Poiché lo Spirito è l’amore che tiene insieme il Padre e il Figlio, e quest’amore brucia sulla croce, allora è grazie alla morte-risurrezione di Cristo che il credente riceve lo Spirito. Ma qual è la funzione dello Spirito? E’ quella di rendere operativo, nell’anima credente, l’amore espresso da Gesù sulla croce: vedere le sue creature che vivono una relazione con il Padre: “Come Tu Padre sei in me ed io in te, siano anch’essi in noi una cosa sola, io in loro, Tu in me, perché siano perfetti nell’unità e il mondo sappia che Tu mi hai mandato e li hai amati come hai amato me” (Gv 17, 21-23). Tutta la storia di Gesù è protesa a portare il discepolo a esperimentare questa relazione con il Padre. Ma chi è questo Padre? “Facci vedere il Padre e ci basta!” (Gv 14,8) diceva Filippo a Gesù. E Gesù mostra se stesso come il volto dentro il quale il Padre si rispecchia: “Chi vede me, vede il Padre. Credetemi: io sono nel Padre e il Padre è in me” (Gv 14, 10-11). Il volto di questo Padre lo si vede guardando Gesù e Gesù lo si capisce guardando la storia che egli vive: “Credetelo almeno per le opere che compio” Gv 14, 11). E’ come se Gesù dicesse: “Il Padre non lo potete vedere, ma vedete me. E Gesù sta andando a dare la vita per gli uomini sulla Croce! Il Padre è in quell’amore lì che io esprimo affidandomi a Lui e andando a morire in vostro favore”. E Gesù opera a favore dell’uomo vincolandosi al Padre, stando attaccato a Lui in una relazione fedele e incrollabile, in una relazione amorosa e tenace, fino a lasciarsi annichilire nella croce. E anche quando il Padre pare assente lo invoca, lo riconosce. Egli sa che il Padre è nascosto dietro a quel silenzio. Quella relazione amorosa e tenace è lo Spirito Santo, che effonderà sulla terra: “E reclinato il capo, emise lo Spirito”. Dio entra in comunione con la sua creatura, fino a volersi perdere nella storia dell’uomo, coinvolgendosi in essa. Questo evento di condivisione, pensato all’interno del dialogo trinitario, è stato illustrato con un racconto efficace da Soren Kierkegaard.
Un re che amava una ragazza poverissima … Tutti i suoi sudditi tremavano alla vista del re, poiché era davvero onnipotente. Egli desiderava sposarla, ma nella sua solitudine era divorato da un pensiero: “Questa figliola sarà davvero felice se mi sposasse? Sarebbe stata capace di dimenticare che lui era il re onnipotente e lei era una ragazza poverissima? Non avrebbe forse segretamente sofferto per questa distanza?”. Forse allora sarebbe stato meglio che rimanesse nel suo nascondimento, amata da un suo pari, contenta della sua povera capanna, ma piena di sincerità nel suo amore, allegra dalla mattina alla sera. Che doveva allora fare il re? Doveva affascinare la ragazza con la propria magnificenza e farle dimenticare, con lo stupore del lusso e la grandiosità regale, la sua origine modesta? Questo forse avrebbe potuto soddisfare la giovane, ma non poteva rendere contento il re, perché egli era preso dall’amore e non voleva glorificare se stesso, bensì quella della ragazza. Che cosa doveva dunque fare? Doveva forse trasformare magicamente la ragazza da umile condizione partorendola per così dire di nuovo? “Ma l’amore non cambia l’amato, bensì cambia se stesso”.
Per Kierkegaard c’è un solo modo per creare un legame di vero amore tra il re e la povera ragazza (tra Dio e la creatura) l’unità mediante un amore che non la soffochi, che non si elevi al di sopra di lei e condivida realmente le sue speranze e i suoi timori, le sue gioie e i suoi dolori. In questo inabissamento prende parte anche lo Spirito. E continua questa sua attività anche nel momento dell’esporsi del Figlio nella natura umana. E come nella vita trinitaria è il vincolo dell’unità, così nella vita terrena del Figlio, non solo è alla sorgente della sua generazione nel seno di Maria, ma lo tiene congiunto in un legame tenacissimo al Padre fino al punto supremo quando sulla Croce ogni legame sembra interrotto. Egli è la forza della risurrezione, perché è l’Amore che resta fedele oltre la morte. Il compito nella vita spirituale è dunque di lasciarci toccare da questo disegno insondabile di Dio di volersi legare a noi attraverso il Cristo nell’energia dello Spirito, in modo da essere introdotti in un saldo legame con il Padre nel vincolo amoroso dello Spirito. Questa è la vita “eterna”, resa possibile già da ora.
Lo Spirito che Gesù invia è dono della sua risurrezione
La condivisione di Dio con la nostra umanità non si ferma all’incarnazione. Egli continua ad operare su ciascun credente mediante il suo Spirito nella storia dei singoli credenti. Questo Spirito infatti è lo Spirito del Cristo risorto. Con – risorti con Cristo, nel battesimo riceviamo continuamente lo Spirito Santo che è il vincolo d’amore che connette il credente a Cristo. Da questa connessione il battezzato ritrova la sua immagine originaria, cioè la sua salvezza. In Gv 20, Gesù si prepara al distacco dai discepoli. “Io vado a prepararvi un posto: quando sarò andato, ritornerò e prenderò con me, perché siate anche voi dove sono Io. (Gv 14, 2-3) … Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paralitico perché rimanga con voi per sempre, 17 lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. 18 Non vi lascerò orfani: verrò da voi. 19 Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più; voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. 20 In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi”.(Gv 14, 1-18; 21). Questo è il sogno di Dio: raccogliere nell’unità dell’amore divino tutte le creature per renderle partecipi di questa vita amorosa.
Lo Spirito trasferisce anche in noi la sua energia di amore
Lo Spirito del Cristo risorto continua la sua funzione unitiva in noi battezzati, attraendoci a Cristo, facendocelo riconoscere presente e risorto dentro la creazione. E’ la rivelazione che Gesù comunica attraverso l’incontro con Nicodemo membro del Sinedrio. Egli ha un’impressione ottima e una valutazione molto alta su Gesù: lo chiama “Maestro venuto da Dio”, titolo che è riservato solo a Mosé e a coloro che conoscono la Legge, la vivono e la insegnano agli altri. Lo dice appoggiandosi sui segni che ha “visto” compiere da Gesù. Ma Gesù gli risponde in malo modo: “Non hai visto bene, Nicodemo!”. “In verità, in verità io ti dico, se uno non nasce dall’alto, non può vedere il regno di Dio».
Hai ragione, Nicodemo, di dire che se non si vede, non si sa. In questo hai ragione. Il problema è che la premessa per voi, farisei, è illusoria. Non è vero che avete visto. Avete visto quello che avete voluto vedere: perciò il vostro sapere è distorto. Per potere vedere e capire bisogna “rinascere dall’alto”. 4Gli disse Nicodemo: “Come può nascere un uomo quando è vecchio? Può forse entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e rinascere?”. 5Rispose Gesù: “In verità, in verità io ti dico, se uno non nasce da acqua e Spirito, non può entrare nel regno di Dio.6Quello che è nato dalla carne è carne, e quello che è nato dallo Spirito è spirito. 7Non meravigliarti se ti ho detto: dovete nascere dall’alto. 8Il vento soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai da dove viene né dove va: così è chiunque è nato dallo Spirito” (Gv 3,3-8)
Qui Gesù sta facendo fare a Nicodemo un percorso di “decostruzione” della mentalità giudaica mostrando che la presunta comprensione di Nicodemo non va oltre la semplice ammirazione. Anche Nicodemo potrà diventare discepolo, ma prima deve uscire dal pensare che il rapporto di Gesù si costruisca su posizioni intellettualistiche, sul sapere. Per entrare nel Regno e diventare “figli di Dio” (Gv 1, 12-13) c’è da operare un distacco. Se ci si ferma alla “carne” (ciò che procede dall’uomo) non si va oltre la carne: “Quello che nasce dalla carne è carne, quello che nasce dallo spirito è spirito”. Nicodemo viene dalla notte e resterà nella notte, finché non accetterà una rigenerazione attraverso un’immedesimazione con Gesù.
Due sono i momenti in cui Nicodemo si riscatta. Il primo quando, da visionario entusiasta dei segni fatti da Gesù passa a difendere Gesù, in base alla legge, chiedendo al sinedrio di ascoltarlo prima di condannarlo: egli dunque si mette dalla parte della verità, cioè di Gesù. Il secondo è l’appuntamento ai piedi della croce, quando con tacita, ma eloquente confessione di fede in Gesù, ne accoglierà insieme a Giuseppe di Arimatea il cadavere crocifisso, contaminandosene ed escludendosi in tal modo dall’imminente Pasqua giudaica. Per la Legge, toccare un cadavere significava diventare impuri. Nicodemo accetta di stare dalla parte di Gesù e di venire come lui escluso dal rito della Pasqua e così partecipare alla nuova Pasqua dell’amore. Solo allora potrà uscire dalla zona d’ombra notturna e venire alla luce perché si è messo dalla parte della verità.
Osserviamo alcune particolarità del testo:
Ànothen: dall’alto. L’alto per la cultura ebraica è il divino: ciò che sfugge alla presa dell’uomo. Il cielo è il luogo da cui è provenuto il soffio di Dio che ha dato la vita alla creazione. Cristo sta parlando della creazione dell’uomo: ormai il peccato è accaduto, l’uomo è tagliato fuori dal “soffio di Dio”, è rinchiuso nell’al di qua. E nell’al di qua non si può vedere bene, perché per vedere bene ci vuol un occhio che abbia una prospettiva larga, quella che si ha quando si guarda dall’alto, da Dio appunto. L’uomo che è chiuso nell’al di qua ragiona secondo la logica della generazione terrena. Di fatto Nicodemo non riesce a vedere quello che Gesù sta dicendo. E fraintende. Gesù vuol far capire a Nicodemo che non si entra nella vita divina con “il sapere”: nella vita si entra mediante una generazione, una nuova nascita. Il sapere non trasmette la vita. Bisogna essere rigenerati. Nel mondo di Dio si entra per una nascita. E non ci si può generare da soli: ci vuole uno che genera. Già nella generazione umana l’uomo non si fa da sé, si riceve. All’origine di ciascuno di noi vi è una passività originaria: “un essere dato”, che è puro dono. Questo stesso modulo della vita biologica si ripete per la vita spirituale. Essa è data e ricevuta, non creata da noi.
Le idee, neppure quelle religiose, riescono a trasmettere la vita. Perché le idee rimangono esterne: Siamo abituati a stare di fronte a Cristo ma così restiamo “esterni”, non “in Cristo”. Si tratta di sentire che il rapporto con lui è “l’unica vita” che abbiamo: non una vita naturale con in più una aggiunta, soprannaturale. Purtroppo abbiamo ridotto il cristianesimo all’insegnamento. Solo con una nuova nascita si va oltre la morte. Solo il respirare in noi la vita di Dio dà la vita che non muore.
“Nascere da acqua e Spirito”, due espressioni per dire una sola cosa: cioè “nascere dall’acqua è lo stesso che nascere dallo Spirito”, poiché lo Spirito è simboleggiato dall’acqua. Come l’acqua è il principio della vita biologica, così lo Spirito è il principio della vita spirituale. Bisogna dunque rinascere dal battesimo: in quanto nel battesimo veniamo ricostituiti nell’immagine originaria della nostra umanità. Non è un caso che nel racconto giovanneo, subito dopo l’incontro con Nicodemo, Gesù vada a battezzare (Gv 3, 22).
“Quello che è nato dallo Spirito è spirito, come il vento”: è libero. E’ come se Gesù dicesse: “Lo spirito non è incatenato dentro a schemi. Nicodemo è la migliore versione dell’AT, perchè non sa vedere la Rivelazione che si sta svelando davanti ai suoi occhi, è sei chiuso nelle sue idee. “La tua carne ti impedisce di vedere”.
“Ma come può accadere questo?”. E con piglio ironico Gesù gli dice: “Tu sei maestro in Israele e non capisci queste cose? Sto parlando della creazione dell’uomo come è descritta nelle prime pagine della Scrittura. Come mai non ti è familiare, tu che sei scriba? Il fariseismo a cui tu appartieni, Nicodemo, non è capace di leggere le Scritture. E’ dal mio costato che sgorgheranno “acqua e sangue” (Battesimo ed Eucaristia): è da qui che si rinasce. Solo se si è rigenerati così si può capire.
Traduciamo il messaggio con termini più esistenziali. Possiamo allora dire che rinascere dall’alto significa nascere dal “desiderio che Dio ha per noi”: egli ci desidera, ci vuole in unione con sé. Egli sente la nostra mancanza. Può apparire strano che Dio senta la nostra lontananza: eppure tutta la storia della salvezza racconta questa sua ricerca di noi. Accorgerci di essere attraversati da questo Suo desiderio (cioè dallo Spirito Santo) e dargli credito: questo ci trae fuori dall’insignificanza della vita e ci fa vivere.
Lo Spirito crea un innesto. Il Padre lo pota e lo purifica (Gv 15).
Lo Spirito dunque ci rigenera. San Giovanni riprende il tema con un’altra immagine. Lo Spirito ci innesta a Cristo. Grazie a questo innesto, Cristo in noi non è più estraneo, esteriore: ma innestati a Lui, partecipiamo della sua vita. Traiamo da Lui la linfa che scorre, cioè lo Spirito che genera vita. Lui è la vite, noi i tralci: “rimanete in me per portare frutto”. Il nostro compito è restare attaccati, ma questo rapporto necessità di potatura. E’ il Padre che pota: Lui sa che cosa togliere, perché sa dove portarci. Il nostro rischio è di volerci aggiustare da noi stessi. La potatura è un arte difficile: avviene in due tempi. E il Vangelo lo rispecchia fedelmente
“Ogni tralcio che in me non porta frutto lo toglie;
e ogni tralcio che porta frutto lo pota/purifica.
La prima potatura è invernale: in cui si tolgono i tralci vecchi e si concentra lo sviluppo della vite solo su due tralci: uno sarà quello che porterà frutto e il secondo, tagliato corto vicino al ceppo, sarà riservato per l’anno successivo. Poi in maggio, quando ormai la pianta si è infoltita di foglie avviene la seconda potatura (“potatura verde”), dove alcuni rametti che già hanno i grappolini devono essere sfoltiti, in maniera da concentrare gli zuccheri sui grappoli e dare aria alla pianta, in modo che, da una parte i germi patogeni abbiano meno possibilità di aggrapparsi e, dall’altra, si possa assicurare una qualità migliore al vino.
Solo il Padre sa quale deve essere il frutto che una persona deve portare. Perciò è Lui che taglia, come vuole. Se uno cerca di aggiustarsi da solo, rovina la sua missione: Dio sa qual è il frutto, e fa accadere nella vita quello che è utile perché venga quel frutto. E poi per portare più frutto, lo purifica, lo sfoltisce.
Il frutto della vite però non è il grappolo, ma il vino.
E il vignaiolo sa come tagliare perché i grappoli che rimangono portino la migliore e più abbondante uva. Non ci si può fermare alla prima tappa della vita, quando uno crea, propone, realizza. Ci vuole il passaggio del torchio per il mosto, prima, e per il vino, poi. E la Pasqua non la si prepara ciascuno da solo. Sono gli altri che ce la preparano. Spesso i più vicini, come per Gesù: i suoi discepoli: “Andate a preparare la Pasqua …”. O Giuda che lo consegna. O Pietro che non riesce a riconoscerlo. L’amore deve maturare in modo pasquale, altrimenti non porta il frutto di un amore fedele, di un amore agapico.
E il legno dei tralci tagliati a che serve?
Nel brano vi è ancora una cosa più curiosa: il legno del vitigno serve solo a fare fuoco. A nient’altro come spiega Ezechiele nel cap. 15: “Che pregio ha il legno della vite di fronte a tutti gli altri legni della foresta? 3 Si adopera forse quel legno per farne un oggetto? Si può forse ricavarne un piolo per attaccarvi qualcosa? 4 Ecco, lo si getta nel fuoco a bruciare, il fuoco ne divora i due capi e anche il centro è bruciacchiato. Potrà essere utile per farne un oggetto? 5 Anche quand’era intatto, non serviva a niente: ora, dopo che il fuoco l’ha divorato, l’ha bruciato, si potrà forse ricavarne qualcosa?” (Ez 15, 3-7)
Quando la linfa passa attraverso il tronco della vite, solo questo legno ha delle caratteristiche di lasciar passare la linfa che arricchirà il succo degli acini, da cui si trarrà il vino. E’ un legno unico che contiene ciò che è necessario per produrre il vino. Una volta compiuta questa funzione si inaridisce. Che cosa intende allora Gesù con l’esempio del legno della vite? E’ l’umanità. Se l’umanità non viene attraversata dalla vita filiale della vita divina finisce tragicamente come ogni essere della creazione. L’uomo realizza se stesso solo se è divino – umano; se è attraversato dalla divino -umanità di Cristo.
Se attraverso la nostra natura umana non scorre un principio che personalizza l’amore, un principio filiale che ci lega al Padre, la tomba e il verme sarà l’ultima stazione. Se invece siamo attraversati dalla vita di Dio, allora l’uomo è capace di avvolgere la sua fatica umana con l’amore che rimane in eterno, perché ritrova la sorgente, il Padre, da cui è venuto e verso cui va.
P. Antonello Erminio
Ascolta audio della prima meditazione
Ascolta audio della seconda meditazione