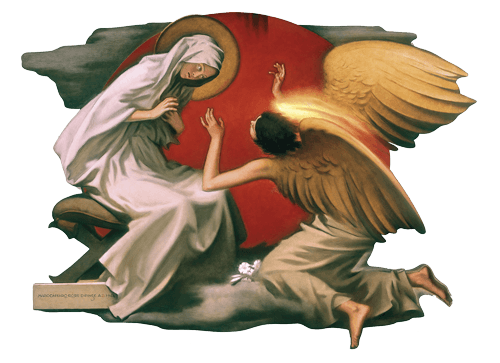Le lettere alle sette chiese (Ap 2, 1- 3,21)
Il “Primo e l’Ultimo”, il “veniente” si rivolge a sette chiese che si trovavano lungo la strada romana che da Efeso portavano a Pergamo, a settentrione: erano tutte sede di autorità statali con tribunali, città dunque in cui si dava particolare impulso al culto dell’imperatore come un dio. E pertanto queste comunità erano inevitabilmente esposte a duri contrasti e a difficili prove.
Queste lettere ci fanno conoscere le tensioni e i problemi della comunità della fine del primo secolo. L’impressione è di trovarci di fronte a comunità reali, normali, alle prese con contraddizioni che sono anche le nostre. Questo fatto c’insegna che non dobbiamo immaginare la nostra comunità in termini ideali e astratti. Le comunità sono fatte dagli uomini e sono imperfette, ma al loro interno vive il Cristo, che rende preziose anche le imperfezioni, quando il clima che vi domina è la carità.
Si vorrebbe vedere la manifestazione del Mistero nella sua compiutezza ed invece esso passa attraverso l’oscurità di lettere, che narrano senza mostrare il Mistero della storia aiutando le comunità cristiane a risvegliarsi alla verità del Crocifisso che esse sono chiamate a vivere nella croce della persecuzione.
Tutte e sette le lettere hanno il medesimo schema: a) l’indirizzo rivolto verso l’angelo che è il custode della Chiesa e il soggetto, Gesù Cristo Signore, che parla e ammonisce la singola chiesa. b) L’esame di coscienza, cioè la descrizione della situazione in cui si trova la città. c) L’invito all’ascolto e d) la promessa del premio.
Chiesa di Efeso
1 All’angelo della Chiesa che è a Efeso scrivi: «Così parla Colui che tiene le sette stelle nella sua destra e cammina in mezzo ai sette candelabri d’oro. 2Conosco le tue opere, la tua fatica e la tua perseveranza, per cui non puoi sopportare i cattivi. Hai messo alla prova quelli che si dicono apostoli e non lo sono, e li hai trovati bugiardi. 3Sei perseverante e hai molto sopportato per il mio nome, senza stancarti. 4Ho però da rimproverarti di avere abbandonato il tuo primo amore (agape). 5Ricorda dunque da dove sei caduto, convèrtiti e compi le opere di prima. Se invece non ti convertirai, verrò da te e toglierò il tuo candelabro dal suo posto. 6Tuttavia hai questo di buono: tu detesti le opere dei nicolaìti, che anch’io detesto.7Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese. Al vincitore darò da mangiare dall’albero della vita, che sta nel paradiso di Dio».
Efeso fiorente città commerciale, megalopoli di circa 300.000 abitanti, dove era famosissimo il tempio di Artemide (dea della Luna e della caccia selvaggia), capitale di provincia e sede del proconsole romano. La prima comunità cristiana era nata con Prisca e Aquila, i credenti commercianti di pelli che Paolo aveva incontrato a Corinto provenienti da Roma. A partire da questo primo nucleo di credenti Paolo può approfondire la sua catechesi, che prende ampio vigore, grazie al fatto di avervi soggiornato tre anni. Anche Giovanni l’apostolo con la madre di Gesù, secondo la tradizione, aveva posto la sua dimora a Efeso. Dunque Efeso ha una straordinaria tradizione di fede.
Il Crocifisso risorto (Colui che tiene in mano le sette stelle e cammina in mezzo ai sette candelabri d’oro”) elogia perché gli efesini non hanno tollerato i malvagi e hanno smascherato i falsi apostoli. La comunità ha mostrato la sua costanza nei confronti delle difficoltà esteriori createle dai giudei o dai pagani a causa della professione di fede in Gesù, quale era stata tramandata dalla tradizione.
Ha però dimenticato “l’amore dei primi tempi”: è stata dimenticata “l’agape”, l’amore fraterno che è la caratteristica dei cristiani. Al presente vi è l’affievolimento di questo amore fraterno, che è – come dice Mt 24, 12 – uno dei segni della tribolazione finale “si raffredderà l’amore di molti”. Rinunciare all’agape verso i fratelli significa distruggere affossare il Vangelo e svuotarlo anche dell’amore di Cristo. Senza la carità tutto si svuota (1 Cor 13). Perciò la raccomandazione 1) ricordarsi dall’altezza da cui si è caduti; 2) ripristinare il primitivo amore fraterno; 3) se questo ravvedimento non avviene “verrà rimosso il candelabro”: la chiesa non farà più luce. Il metodo per ripristinare il fervore primitivo è dunque “fare memoria”: non possiamo risuscitare il passato, ma possiamo permettere al presente di illuminarsi grazie a quel passato.
Alla chiesa di Efeso è riservato, in ogni caso un elogio: di aver allontanato i Nicolaiti: il nome probabilmente deriva dal loro fondatore. Non si sa granché di loro. Probabilmente appartengono alla tendenza gnostica, che o negava la vera carne di Gesù Figlio del Padre, oppure il Vangelo veniva interpretato come una dottrina e non come l’esperienza della carità (cf 1 Gv 1, 1-3): “7Sono apparsi infatti nel mondo molti seduttori, che non riconoscono Gesù venuto nella carne. Ecco il seduttore e l’anticristo! 8Fate attenzione a voi stessi per non rovinare quello che abbiamo costruito” (2 Gv 1, 7-9). Chi resta fedele potrà riappropriarsi dell’albero della vita, che era stato perduto con il peccato: e quindi ristorarsi nella sovrabbondante pienezza del rapporto di intimità con Dio (paradiso), dove vi sarà piena trasparenza (faccia a faccia: “conoscerò come sono conosciuto” 1, Cor 13, 12 oppure come Mosé che “la pelle del suo viso era diventata raggiante, poiché aveva conversato con il Signore” (Es 34, 29).
Chiesa di Smirne
All’angelo della Chiesa di Smirne scrivi: Così parla il Primo e l’Ultimo, che era morto ed è tornato alla vita: [9] Conosco la tua tribolazione, la tua povertà – tuttavia sei ricco – e la calunnia da parte di quelli che si proclamano Giudei e non lo sono, ma appartengono alla sinagoga di satana. [10] Non temere ciò che stai per soffrire: ecco, il diavolo sta per gettare alcuni di voi in carcere, per mettervi alla prova e avrete una tribolazione per dieci giorni. Sii fedele fino alla morte e ti darò la corona della vita. [11] Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese: Il vincitore non sarà colpito dalla seconda morte.
L’antica città commerciale di Smirne non era inferiore a Efeso per ricchezza e prosperità. La comunità cristiana aveva dovuto soffrire parecchie persecuzioni e insidie da parte dei giudei (che hanno perso la loro dignità di “popolo di Dio” ed essersi degradati a “sinagoga di satana”: 2, 9), e di cui fu vittima più tardi anche il vescovo Policarpo, ma che forse era già presente in questa persecuzione, poiché quando subì il martirio egli dice che era stato perseguitato da 86 anni. Nessuna parola di biasimo per questa chiesa. Soltanto l’invito a comprendere che “povertà e calunnia” non si contraddicono con l’essere discepoli di Cristo, anzi “questa è la ricchezza”: la persecuzione durerà “breve tempo” (questo è il significato del 10: cf Dan 1, 12. 14; Gen 24, 55), e la fedeltà sarà premiata con la corona di gloria. La “seconda morte” è la morte eterna: stare legati al “Primo e l’Ultimo” assicura il legame che sottrae all’incertezza del futuro e radica nell’amore eterno.
Chiesa di Pergamo
[12] All’angelo della Chiesa di Pèrgamo scrivi: Così parla Colui che ha la spada affilata a due tagli: [13] So che abiti dove satana ha il suo trono; tuttavia tu tieni saldo il mio nome e non hai rinnegato la mia fede neppure al tempo in cui Antìpa, il mio fedele testimone, fu messo a morte nella vostra città, dimora di satana. [14] Ma ho da rimproverarti alcune cose: hai presso di te seguaci della dottrina di Balaàm, il quale insegnava a Balak a provocare la caduta dei figli d’Israele, spingendoli a mangiare carni immolate agli idoli e ad abbandonarsi alla fornicazione. [15] Così pure hai di quelli che seguono la dottrina dei Nicolaìti. [16] Ravvediti dunque; altrimenti verrò presto da te e combatterò contro di loro con la spada della mia bocca. [17] Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese: Al vincitore darò la manna nascosta e una pietruzza bianca sulla quale sta scritto un nome nuovo, che nessuno conosce all’infuori di chi la riceve.
Pergamo era un’antica capitale del regno degli Attalidi e poteva sostenere anche in epoca romana il confronto con Efeso. La città era ricca di tempi pagani, uno dei quali era dedicato a Zeus, in cui gli imperatori ricevevano onori divini. Non era facile, in una città come questa, attestare con fermezza la fede in Gesù risorto. Tuttavia i cristiani sono rimasti fedeli anche quando per intimorirli i giudei hanno linciato ed ucciso un loro fedele, Antipa. La loro fedeltà è lodevole, ma al loro interno vi sono alcuni che condividono la dottrina di Balaam, rimprovera il Signore. Nella storia ebraica Balaam era stato chiamato un tempo da Balac, re dei Moabiti per maledirli. E’ il protagonista di un caratteristico episodio avvenuto durante gli ultimi tempi della dimora degli Israeliti nel deserto, allorché, risalendo lungo le rive orientali del Mar Morto e del Giordano, si accingevano ad entrare in Palestina. Allorché gl’Israeliti, dopo aver vinto i due re amorrei Sehon e Og e conquistati i loro regni, si accamparono sulle pianure di Moab, il re di questa regione, Balac figlio di Sefor, temette di far la stessa fine dei due re precedenti: prevedendo d’altronde che con le armi non avrebbe potuto resistere alla prevalenza degl’Israeliti, pensò ricorrere al mezzo più efficace e sicuro della magia. Egli quindi spedì dei messi a Balaam. Ma Balaam ricevette la proibizione di Dio di andare a maledire gli Israeliti. Ciononostante, messosi in cammino, l’asina che cavalcava, vedendo un angelo che gli sbarrava la strada, si spaventò e deviò per i campi; Balaam, a cui non era ancora concesso di scorgere l’angelo, cominciò a picchiarla: ma invano, perché ovunque la bestia si volgesse, le si parava davanti l’angelo. Insistendo B. a picchiare, “Jahvè aprì la bocca all’asina” la quale parlò lamentandosi del modo in cui era trattata. Solo dopo altre istanze da parte di ambedue gl’interlocutori “Jahvè aprì gli occhi a Balaam”, che poté scorgere l’angelo. Questi scagiona l’asina: B. si dichiara pronto a tornare addietro, ma l’angelo gli permette di proseguire, purché dica soltanto ciò ch’egli gli suggerirà. Giunto B. presso il re di Moab, fu condotto su un’altura, donde poté scorgere l’accampamento degl’Israeliti; ivi B. fece costruire sette altari, e sopra ciascuno immolò un giovenco e un montone; di lì a poco, entrato in relazione con Dio, pronunciò davanti al re il suo primo vaticinio, che però invece di essere di maledizione fu tutto un’esaltazione della potenza della nazione accampata là sotto. Allora “Balac disse a Balaam: Che mi hai fatto? Ti ho preso per maledire i miei nemici, ed ecco che li hai benedetti! – Questi rispose e disse: Non debbo io badare a proferire sol ciò che Jahvè mi mette in bocca?” Condotto B. successivamente sopra altre due alture e premessi gli stessi sacrifici, pronunciò altri due vaticinî, che furono egualmente di esaltazione e benedizione per il popolo d’Israele. Dopo la terza volta il re, disperando del buon successo, anzi temendo nuove benedizioni ai suoi nemici, comanda a B. di partirsene in fretta (Num 22-24). In epoche successive il giudaismo vide in lui l’istigatore all’idolatria (Num 31, 16). Egli avrebbe indotto le moabite a fornicare con gli Israeliti (Num 25, 1 ss.). Insomma egli è il tipo di quegli eretici che invitano a commettere due peccati che Paolo esorcizza per la comunità credente: mangiare carni sacrificate agli idoli o in altre parole affidarsi alla magia idolatrica entrando in comunione (mangiando) con gli dei falsi (1 Cor 8-10) e quello di darsi alla fornicazione, dimenticando che il corpo è il tempio del Signore (1 Cor 6, 12-20). I nicolaiti ne seguivano l’esempio. Tutto ciò rivela qual è il male rimproverato: queste dottrine libertine sono causa per cui molti cristiani accettano l’idea che per essere cristiani non è necessario separarsi dal mondo pagano, ma si può continuare a partecipare al loro modo di vita, senza che ne venga intaccato il vero io dei cristiani. Questa etica libertina è insidiosa per il cristianesimo, poiché è una mondanizzazione o un compromesso con la logica mondana. Bisogna dunque ravvedersi. Il premio è detto attraverso due metafore: il dono della manna e la consegna di una pietruzza bianca con la scrittura di un nome nuovo. La prima metafora si riferisce alla tradizione giudaica secondo la quale il profeta Geremia, prima della distruzione di Gerusalemme, aveva messo al sicuro l’arca dell’alleanza e le cose in essa contenute, fra cui una brocca piena di manna (2 Mac 2, 48). Si sperava che alla fine dei tempi Dio avrebbe nuovamente nutrito il suo popolo con la manna come aveva fatto nel deserto, segno della salvezza definitiva. La seconda metafora è invece incerto il suo significato. Tuttavia può riferirsi all’uso molto diffuso nell’antichità, di portare per proteggersi amuleti sui quali era scritto un nome magico e segreto. Conoscere un nome significa esercitare un potere su colui che lo porta. Chi aveva con sé tali amuleti e conosceva il significato delle parole che vi erano scritte era protetto contro gli spiriti maligni e i demoni. Il “nome nuovo” che protegge è evidentemente il nome di Cristo.
P. Antonello Erminio
Ascolta l’audio della seconda meditazione.