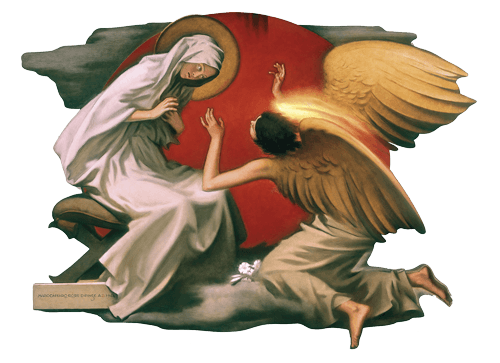Un genere particolare di scrittura e di racconto: il genere apocalittico
- Sul finire dell’AT si è sviluppato un vasto movimento letterario e spirituale chiamato apocalittico. E’ una riflessione sviluppata in un tempo di crisi. Sono tempi difficili, in cui non si vede chiaro il futuro. Vi è il dominio dell’impero che tutto sembra ingoiare nel suo potere. La religiosità ebraica si è “formalizzata” e standardizzata: non è capace di novità. L’evento di Gesù è stato scartato dal popolo eletto. Il tempio ebraico, attorno a cui gli ebrei avevano sognato la riunificazione della loro religiosità, nell’anno 70 d.C. è stato distrutto da Tito. Un mondo sembra finire. Le piccole comunità cristiane, nel loro difficile passaggio dalla religiosità ebraica alla novità evangelica, sono all’esterno, sotto persecuzione e, al loro interno, sono insidiate da varie deformazioni del messaggio originario. Nel contatto con il mondo greco vi è l’insorgere dello gnosticismo o una intellettualizzazione dell’evento di Cristo, reso svaporato nella sua realtà storica e nella originalità evangelica, per essere mescolato con riti magici, mitici e pagani. Insomma, di fronte a questa crisi di cultura e di passaggio storico vi è incertezza e timore. Ed il genere apocalittico di narrare ha come propria chiave di lettura di interpretare la storia con la fiducia in Dio. Per l’intervento di Dio, il giudizio sarà fatto e le situazioni presenti saranno capovolte. La storia è nelle mani di Dio e Lui la conduce anche all’interno della crisi umana: si tratta di capire se si è disposti a fidarsi di Dio. Ecco la Chiesa dell’Apocalisse è una chiesa che fa affidamento nel Cristo risorto, vincitore della storia, che è l’Agnello immolato che ha “il potere di aprire il libro [della storia], avendo riscattato con il suo sangue uomini di ogni tribù, lingua popolo e nazione” (Ap5, 9).
- L’esperienza apocalittica è alimentata da due radici. Da una parte, essa nutre pessimismo nelle forze dell’uomo e del mondo presente. Da un’altra, essa si affida nelle possibilità di Dio di generare un mondo nuovo. Questa esperienza ha alle sue spalle la visione storica caratteristica dei profeti, per i quali la storia è nelle mani di Dio. Nessun evento accade a caso e tutti gli eventi sono orientati alla costruzione del Regno di Dio nel mondo. Un vero credente sa riconoscere nella storia il disegno di Dio, in cui nulla andrà perduto. Egli controlla la storia. Però l’esperienza apocalittica, consapevole dello scacco che l’affermarsi di Dio nella storia sembra subire, tende a proiettare oltre la storia, alla fine, la soluzione. Essa si focalizza unicamente sul futuro, trascurando il presente che è malvagio, infido e corrotto. Questo modo di sentire, da una parte, è giusto poiché riconosce che il mistero di Dio è trascendente e non ci si può impossessarsene. Ma, da un’altra parte, può rischiare di disinteressarsi di questo mondo, abbandonandolo al suo destino. Questo rimando totalmente al futuro non coincide con il pensare cristiano, poiché il Crocifisso è già vittorioso dentro alla storia. E il credente è chiamato con il suo impegno a rendere presente proprio la risurrezione di Cristo già ora, dentro alla sua vita. Guardando e considerando l’evento di Cristo come germe deposto negli avvenimenti del tempo, egli lascia che il Cristo cambi la sua vita e la renda il più simile possibile a quella carità, che Gesù ha vissuto sulla terra come primo bocciolo della nuova creazione.
- Il linguaggio e il pensiero apocalittico fanno della ruminazione di testi antichi l’anima di fondo del loro raccontare. Il testo dell’apocalisse è riscrittura di tantissime citazioni dirette e indirette del Primo Testamento. Soltanto conoscendo queste citazioni si può comprendere qualcosa degli enigmi che vengono formulati attraverso visioni piene di immagini. L’apocalisse è l’ultimo libro del Nuovo Testamento. E da questa posizione può sviscerare il pensiero apocalittico, però lo destruttura, poiché l’irruzione di Dio nella storia che la tradizione apocalittica riservava per il futuro, per l’Apocalisse è già avvenuta nella storia di Gesù e particolarmente nella sua Croce: questa è la vera manifestazione di Dio nella storia. Il centro dell’Apocalisse infatti è il Gòlgota. Il momento del giudizio finale è il momento in cui l’Agnello, ritto e sgozzato rivela la sua centralità rispetto a tutto il disegno della creazione e della storia narrato nelle Scritture della tradizione giudaica. La Croce è il momento in cui tutta la storia si dischiude nel suo senso; ma, nello stesso tempo, è una “ri-velazione”, viene cioè nuovamente velato quella luce che è apparsa sulla croce, poiché la storia resta nuovamente velata con le sue contraddizioni e i fallimenti della libertà umana. L’apocalisse dunque è la meditazione sulla storia umana a partire dal centro della Croce. In altre parole, è la rivelazione della Verità della storia, cioè dell’amore/agape che prende il posto del Potere, quel potere impersonato “dal drago rosso dalle sette teste” (Ap 12, 3). Drago che è ogni forma di potere che vuole la supremazia sulla storia, forma che può assumere volti e facce tanto diversificate e sempre attuali: i Romani o i Parti ai confini dell’impero, fino al piccolo personale “potere” con cui ognuno ricerca la propria autoaffermazione, il dominio sugli altri e la propria gloria. Forme con cui “il serpente antico, colui che è chiamato diavolo e il Satana, seduce tutta la terra abitata” (Ap 12, 9)
Domande per l’oggi:
Quale senso della storia abbiamo? Abbiamo la certezza che tutti gli avvenimenti sono guidati al bene da Dio? Nutriamo un sentimento positivo della nostra storia che sta attraversando momenti drammatici di confusione? E’ vero il nostro tempo pare descritto alla lettera da san Paolo nello scritto ai Romani 1, 18-32: ma dentro a tutto questo è chiesto a noi di radicarci nella fede. Se ci nutriamo di fede, non ci smarriamo. Lo smarrimento nasce dalla preoccupazione di fare della terra il nostro destino: è un inganno che il tempo che passa si incarica di svelare!
Ascolta l’audio della 1a meditazione.
Ap 1, 4-9: L’autore in sintonia con la situazione di persecuzione delle chiesa d’Asia
4Giovanni, alle sette Chiese che sono in Asia: grazia a voi e pace da Colui che è, che era e che viene, e dai sette spiriti che stanno davanti al suo trono, 5e da Gesù Cristo, il testimone fedele, il primogenito dei morti e il sovrano dei re della terra.
A Colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, 6che ha fatto di noi un regno, sacerdoti per il suo Dio e Padre, a lui la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen.
Insieme ai suoi lettori Giovanni, a cui il Signore si manifesta glorioso, è solidale con i suoi fratelli e l’intera comunità che è nella persecuzione (“esiliato nell’isola di Patmos” v. 9). Questo è l’ambiente in cui il messaggio è nato: una comunità perseguitata. Egli è stato condotto in questa isola del gruppo delle Sporadi, davanti alle coste dell’Asia Minore, che i romani usavano come luogo di confino e di miniere per estrarre minerali. Il motivo per cui è stato allontanato dalle sue comunità e condotto a Patmos è la Parola di Dio e la testimonianza di Gesù (v. 2). Qui nel giorno di Domenica (v 10), Giovanni si sentì in modo particolare unito alle sue comunità, che celebravano il giorno del Signore, e viene rapito in un’estasi. L’estasi non è uno stato di incoscienza, ma l’entrare più profondamente nel rapporto con il Mistero che si sta rivelando.
Il Mistero di Dio, nel quale il Veggente saluta le Chiese, viene presentato con molta ricchezza di perifrasi:
1) “Grazia e pace a voi da Colui che è, che era e che viene, dai sette spiriti (= pienezza dello Spirito o Spirito Santo) che stanno davanti al suo trono”(v. 4)”: qui si riprende e si amplia Es 3, 14. Egli è l’immutabile, dominatore del tempo (passato, presente e futuro): non è detto “colui che sarà”, ma “colui che viene”, poiché la storia è sotto il giudizio di Dio.
2) “… e da Gesù Cristo, il testimone fedele, il primogenito dei morti e il principe dei re della terra”. Di Gesù si usano tre predicati: è colui 1) che ha reso testimonianza alla verità (cf Gv 18, 37); 2) restando fedele fino alla morte (Ap 2, 13); è colui che è entrato nella morte e vi è rinato risorto come primogenito (Col 1, 18); 3) infine, il Glorioso che è stato costituito re su tutti i regni (Ef 1, 20). Dunque il Cristo glorificato, che è passato attraverso la morte, manifestando il suo amore per noi, costituisce la sicurezza di questo popolo, che ora sta soffrendo, ma “è già il suo regno di sacerdoti costituito per il Padre”, che cioè esiste a lode di Dio. Dunque: “A Colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue …. Gloria e potenza nei secoli” (Ap 1,6). Il Padre con lo Spirito e Gesù presiedono alla condizione sofferente della Chiesa. Questa si trova dunque in mani buone.
Contenuto del libro
 7-8: Prolungamento per preannunciare il contenuto del libro: la venuta escatologica del Crocifisso risorto è già posta dentro la storia e la determina. Già viene, non solo verrà.
7-8: Prolungamento per preannunciare il contenuto del libro: la venuta escatologica del Crocifisso risorto è già posta dentro la storia e la determina. Già viene, non solo verrà.
7Ecco, viene con le nubi e ogni occhio lo vedrà, anche quelli che lo trafissero, e per lui tutte le tribù della terra si batteranno il petto. Sì, Amen! 8Dice il Signore Dio: Io sono l’Alfa e l’Omèga, Colui che è, che era e che viene, l’Onnipotente!
L’autore si serve di due passi dell’AT (Dan 7,13 e Zac 12, 10) ripresi nel NT da Mt 24,30 e Gv 19, 37. “Sulle nubi del cielo” così i primi cristiani (in conformità a Dan 7, 13) si aspettavano che il Figlio dell’Uomo sarebbe venuto per giudicare tutti gli uomini. Sorgerà allora il rimorso di quelli che lo hanno ingiustamente trafitto.
E questo Dio immutabile attraversa il tempo (“Io sono l’Alfa e l’Omega”), poiché il libro della storia, scritto con le lettere dell’alfabeto, è sotto il giudizio di “Colui che è, che era e che viene”.
Il simbolismo delle lettere è passato al giudaismo dal mondo greco. L’intero alfabeto greco di 24 lettere veniva messo in rapporto con il tutto: le 24 ore del giorno erano connesse con le 24 lettere dell’alfabeto e collegate con i dodici segni dello zodiaco. Dio dunque è il Tutto del tempo.
Perciò i suoi nemici possono strepitare finché vogliono, le potenze del caos possono sollevarsi e assalire il popolo di Dio: a Lui spetta la prima e l’ultima parola, l’Alpha e l’Omega.
Visione del “Figlio dell’Uomo” ( Ap 1, 9-20)
Nel descrivere il senso della storia del mondo l’Ap non si serve di una piatta “narrazione storica” delle cose che accadono, ma si serve di “visioni”, che sono come lampi nella notte: illuminano per un momento, anche se poi tutto ridiventa oscuro ossia piomba nel mistero della trascendenza di Dio. Non dobbiamo perciò ascoltare la sua narrazione con lo sguardo del cronista che vuole conoscere e descrivere i fatti nel loro accadere oggettivo, come si trattasse di una cronaca giornalistica corredata pure di fotografie.
Le visioni sono simboli che rimandano ad un significato. Non bisogna fermarsi alle figure e ai colori. Dei simboli sono importanti la dinamica e il movimento che mettono in moto nel pensiero e nell’animo (pensiamo a un oggetto simbolico che ci viene dato da una persona cara) e i colori (pensiamo a qualche quadro di pittura moderna tutta pennellate che quasi abbagliano). In essi domina lo splendore e l’impressione che suscitano. Così subito il testo si apre con una prima visione con tre scene: il narratore è rapito dallo Spirito; la visione del Figlio dell’Uomo; la reazione della visione sul narratore:
a) 9Io, Giovanni, vostro fratello e compagno nella tribolazione, nel regno e nella perseveranza in Gesù, mi trovavo nell’isola chiamata Patmos a causa della parola di Dio e della testimonianza di Gesù.10Fui preso dallo Spirito nel giorno del Signore e udii dietro di me una voce potente, come di tromba, che diceva: 11«Quello che vedi, scrivilo in un libro e mandalo alle sette Chiese: a Èfeso, a Smirne, a Pèrgamo, a Tiàtira, a Sardi, a Filadèlfia e a Laodicèa».
b) 12Mi voltai per vedere la voce che parlava con me, e appena voltato vidi sette candelabri d’oro 13e, in mezzo ai candelabri, uno simile a un Figlio d’uomo, con un abito lungo fino ai piedi e cinto al petto con una fascia d’oro. 14I capelli del suo capo erano candidi, simili a lana candida come neve. I suoi occhi erano come fiamma di fuoco. 15I piedi avevano l’aspetto del bronzo splendente, purificato nel crogiuolo. La sua voce era simile al fragore di grandi acque. 16Teneva nella sua destra sette stelle e dalla bocca usciva una spada affilata, a doppio taglio, e il suo volto era come il sole quando splende in tutta la sua forza.
c) 17Appena lo vidi, caddi ai suoi piedi come morto. Ma egli, posando su di me la sua destra, disse: «Non temere! Io sono il Primo e l’Ultimo,18e il Vivente. Ero morto, ma ora vivo per sempre e ho le chiavi della morte e degli inferi. 19Scrivi dunque le cose che hai visto, quelle presenti e quelle che devono accadere in seguito. 20Il senso nascosto delle sette stelle, che hai visto nella mia destra, e dei sette candelabri d’oro è questo: le sette stelle sono gli angeli delle sette Chiese, e i sette candelabri sono le sette Chiese.
La prima sensazione è di essere di fronte a qualcosa di luminoso e di sfuggente. Giovanni viene investito prima di tutto da una Voce che dà un comando imperioso (“voce potente come di tromba”). Dio lo si “sente”, non lo si vede: lo si può intuire indirettamente attraverso l’alone di ambiguità di ogni simbolo, ma resta mistero. Dio si comunica attraverso una voce che spiega e una visione da interpretare. Mentre “il vedere” è un’operazione con la quale si tiene sotto controllo la realtà, dissolvendo ogni ombra, il “sentire” non dissolve il mistero, implica il dargli credito: implica la fede e la semioscurità. E l’uomo vorrebbe controllare. Ma Dio si dà nella penombra del mistero di una gloria maestosa che abbaglia e impone il silenzio e lo stupore. Si ode la voce, ma si resta abbagliati dallo splendore che irradia. La visione rimane avvolta dall’interrogazione: che sarà? Che cosa vuole?
Il simbolismo attraverso cui Dio si manifesta è mutuato dall’AT (Dan 7, 9-15). Prima di tutto vede “sette candelabri d’oro”, non si tratta dell’unico candelabro d’oro a sette braccia posto nel santuario e che ardeva senza interruzione davanti a Dio. Questo cambiamento indica la diversità tra l’AT e il NT: Gesù Cristo è il risultato e la conclusione dell’AT. Al vs 20 spiega che questi candelabri sono “le sette lampade della sette Chiese”. Dalle chiese dunque traluce il Cristo: il Cristo glorioso si serve della luce della Chiesa per continuare la su apresenza el mondo. La figura del Figlio dell’Uomo si rivela “in mezzo” a queste chiese che brillano come i sette candelabri. Il Cristo non è slegato dalla sua Chiesa, ma è in mezzo a essa.
“Uno simile a Figlio d’Uomo”: è il Signore risorto, glorioso, che siede in trono presso Dio e che ha ricevuto il dominio su tutto il creato, il Pantocrator, come in Fil 2, 9-11: “Per questo Dio lo ha esaltato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sotto terra, e ogni lingua proclami: Gesù Cristo è Signore, a gloria di Dio Padre”. La lunga veste di cui è coperto il Figlio dell’Uomo è il simbolo della sua dignità di Sommo Sacerdote (Es. 28, 4. 27); e la cintura d’oro che gli fascia il petto era portata dai re (1 Mac 10, 89). La sua figura è circonfusa di luce che capo e capelli splendono bianchi come la neve. Il rimando è alla trasfigurazione di Gesù sul monte. I suoi occhi come fiamme di fuoco (Dan 10, 6) penetrano ogni cosa, per cui nulla può rimanergli nascosto. I suoi piedi brillano come bronzo purificato appena versato dal crogiolo. La sua voce si può paragonare solo al rumore di ribollenti cascate. Nella mano destra (la destra è il lato della forza e della potenza) egli tiene sette stelle: il Figlio dell’uomo è signore di tutto: questo vogliono dire le sette stelle. Dalla sua boca esce una spada acuminata a doppio taglio, e significa che il Cristo è il giudice (Is 11, 4; 49, 2) che divide la storia in due o la storia nel bene o nel male (cf Ap 19, 15). Lo splendore del suo volto è come la luce del sole quando a mezzogiorno splende in pienezza.
L’effetto che la visione suscita in Giovanni lo fa “cadere a terra come morto”. E’ l’angoscia che assale l’uomo al manifestarsi del Mistero di Dio: esso è sempre diverso dai suoi pensieri, rompe schemi, spariglia idee. E’ dirompente. Anche Gesù si è presentato così: “non lo capivano!”. Le sue parole restavano oscure e il suo agire lo conducevano in mezzo ai guai del rifiuto. Ogni discepolo di fronte all’apparire di Dio sente che deve tirarsi indietro ed esperimentare la morte per fare spazio a lui. Ma Gesù tocca il veggente tramortito. Da questo contatto sgorgano forze vivificanti. Nelle parole che dice per fugare la paura, Gesù si attribuisce i titoli onorifici più eccelsi. Afferma di essere “il primo e l’ultimo” come Dio (Ap 1, 8), “il Vivente” come Dio, il solo vivente, a differenza degli dèi e degli idoli inanimati. “Prima ero morto ma ora vivo per sempre”: queste parole collocano Gesù sullo stesso piano di Dio. “E ho potere sulla morte e sugli inferi”: la discesa agli inferi, sottraendo le chiavi al regno della morte, lo rende signore anche di questo regno tenebroso. E perciò la morte stessa ha perso il suo carattere spaventoso agli occhi della comunità. In essa ormai regna la luce (“sette candelabri”) ed è protetta dalla custodia di “sette stelle che sono gli angeli della sette Chiese” (Ap 1, 20): e queste “sette stelle sono tenute nella mano destra (quella vincente) del Figlio dell’Uomo” (Ap 1, 16).
Domande per l’oggi.
Questa prima pagina dell’Ap rivela che la comunità cristiana è saldamente piantata sulla certezza del Signore risorto è il senso di tutta l’esistenza propria e del cosmo. Questa certezza è un sentimento di vita che sfonda tutte le oscurità del male personale e le avversità della storia. C’è un affetto per l’evento del Cristo, riconosciuto presente, che dà sicurezza ai cuori. Tutti i nostri guai e paure derivano dal fatto che questa certezza si è oscurata e non scende più fino alle pieghe segrete dell’umano. Gesù ebbe a dire: “Quando il Figlio dell’Uomo verrà, troverà ancora la fede sulla terra?” (Lc 18, 8).
Nota: i numeri dell’Apocalisse
I numeri dell’Apocalisse non appartengono all’aritmetica, ma alla simbolica.
a) Il numero che compare più spesso è il sette. Sette sono le comunità a cui si rivolge (1, 4.11), sette gli spiriti di cui si parla (1, 4; 4, 5; 5, 6); sette sono i candelabri (1, 12. 20; 2, 1) sette le stelle (1, 16.20); il libro della storia ha sette sigilli (5, 1), l’angelo con sette corna e sette occhi (5, 6), sette trombe nelle mani dei sette angeli ((, 2 ss), sette tuoni (10, 3), sette piaghe in sette coppe (15, 1.7; 16, 1 ss). Per la religione astrale babilonese le sette stelle venerate come divinità reggevano il corso del cosmo, perciò nell’antichità il sette era considerato come il numero che indica l’universo. Questo pensiero è penetrato nella letteratura apocalittica ed ha assunto il significato della perfezione del divino e la pienezza del suo dominio.
La metà di sette, contrapposta al numero pieno e perfetto, viene usato per indicare un tempo limitato e breve, cioè tre anni e mezzo: 12, 14 = tre tempi e mezzo; 11, 2. 13, 5 = 42 mesi; 11, 3 = 1260 giorni, cioè 360×3+360:2; oppure tre giorni e mezzo: 11, 9. 11.
b) Un significato particolare era anche attribuito al numero quattro: alle quattro estremità della terra, ritenuta piatta (20, 8) stanno le quattro creature angeliche (7, 1) che reggono la volta celeste e comandano le forze della natura (9, 14 ss). Le quattro stagioni sono accompagnate da quattro grandi costellazioni come esseri giganteschi che reggono la volta celeste (4, 6). Nell’apocalisse il rapporto con la religione astrale scompare, ma il numero quattro rimane riferito ugualmente all’ordine cosmico.
c) In origine anche il numero dodici è derivato dalle concezioni della religione astrale: in 12 mesi l’anno compie il suo ciclo (22, 2) e a Babilonia erano attribuiti onori a 24 stelle (4, 4) che si trovavano metà a nord dello zodiaco e metà a sud. Il numero 12 dunque è considerato segno della perfezione e della completezza. La regina del cielo è adorna di 12 stesse (12, 1), la città celeste è circondata da un muro che poggia su dodici fondamenta e ha 12 porte, che sono 12 perle (21, 12-14, 21). La nuova Gerusalemme si estende a forma di quadrato di 12.000 stadi di lato (21, 16). Dodici tribù formano il popolo di Dio (7, 5-8), che viene descritto anche il multiplo di 12, cioè 144.000, ossia la schiera compatta e completa degli eletti (7, 1-8; 14, 1-5). La storia si svolge nell’ampio spazio di una settimana cosmica, perciò si era pensato molte volte che il suo corso durasse 7000 anni e che l’ultimo giorno della settimana cosmica fosse di mille anni (20, 2-7). L’apocalittica giudaica ha ripreso dalle antiche concezioni astrali la considerazione dei numero a cui attribuisce significati misteriosi, ma senza più venerare gli astri, che vengono visti soltanto come creature di Dio.
d) Il numero dieci (“dieci corna del drago rosso” Ap 12) è un codice numerico ed indica “il male”; ma il male è sempre limitato, perciò il numero dieci indica il limite di una grandezza che pure appare smisurata a livello terrestre.
|
Il numero 666 (13, 18) è la cifra della “bestia”, la sua essenza, è un sovrano atteso per l’imminente futuro, il quale imporrà l’osservanza incondizionata del culto imperiale con una intransigenza mai vista prima. L’allusione enigmatica (“Chi ha intelligenza calcoli il numero della bestia: essa rappresenta un nome d’uomo” 13, 18) si basa su un gioco caro a ebrei e giudei, la cosiddetta gematria, che consisteva nell’esprimere ogni lettera di una parola con il valore numerico ad essa corrispondente, fare la somma e poi parlare soltanto nella forma velata del numero. Giudei e greci non aveva segni grafici speciali per i numeri, ma usavano le lettere, ciascuna corrispondente a un determinato valore: a = 1; b = 2; i = 10; k = 20 ecc. Si poteva quindi trasformare qualsiasi parola in un numero facile da calcolare. Era invece difficile risalire dal numero alla parola in esso nascosta, poiché la chiave di assegnazione delle lettere ai numeri era segreto: e soltanto chi era iniziato alla chiave poteva capire di chi si parlava. Questo gioco era estremamente popolare, al punto che su una parete di Pompei si può leggere la frase: “Amo quella ragazza che ha il numero 545”. Evidentemente soltanto alcuni amici che conoscevano la chiave di lettura potevano capire di chi si trattava, ma per gli altri il significato restava segreto.
Così per il numero 666. Non sono mancati tentativi, e il più probabile è che il numero sia calcolato con l’alfabeto ebraico e significhi Nero Caesar.
P. Antonello Erminio