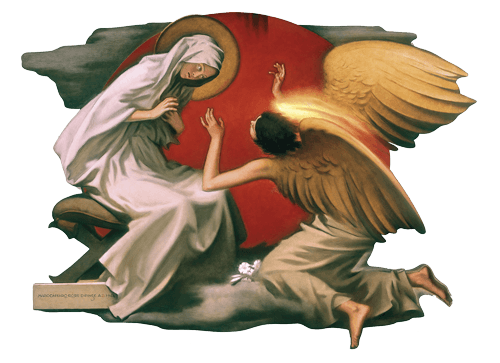Sabato 25 novembre dalle ore 15 alle 17.30 P. Antonello Erminio guiderà la seconda tappa del percorso formativo-spirituale. Tema dell’incontro: “Attorno al pozzo: un dialogo di libertà“ (Gv 4,4-41).
Sabato 25 novembre dalle ore 15 alle 17.30 P. Antonello Erminio guiderà la seconda tappa del percorso formativo-spirituale. Tema dell’incontro: “Attorno al pozzo: un dialogo di libertà“ (Gv 4,4-41).
Ascolta l’audio della sua meditazione:
In questo racconto vediamo lo stile di Gesù. Egli, per introdurre l’uomo a capire che può essere se stesso soltanto in una relazione di “adorazione del Padre in Spirito e Verità”, si avvicina a Lui, si fa prossimo. E’ il suo stile. Comunica incontrando. Così accostandosi alla donna di Samaria nel suo contesto abituale e feriale la porta a ritrovare in se stessa questo dinamismo di rapporto con il Padre che solo può saziare la sete.
L’incontro avviene attorno al pozzo di Sicar. E il nome Sicar porta in sé un simbolo. Significa “qualcosa di intasato”. L’uomo purtroppo è intasato: qualcosa lo separa dalla sorgente e, perciò, è come prosciugato. Questo è il punto di partenza dell’uomo: c’è qualcosa in noi che ci chiude su noi stessi. Nel nostro tempo questo si chiama con un nome altisonante e accattivante: “autorealizzazione”. Ma è una trappola. L’uomo non ritrova se stesso attraverso l’autosaturazione dei desideri e l’auto-soddisfazione dei bisogni. Anzi, più l’uomo cerca se stesso e più si perde.
1. La verità della vita: entrare in un rapporto dialogico con la fonte
Nell’ora più assolata e solitaria del giorno, dialogando con una donna di Samaria, Gesù (la Parola fatta carne) fa venire alla luce la verità della sua persona, nascosta nelle pieghe oscure della sua storia di donna presumibilmente chiacchierata e certamente reticente. Nel rapporto sincero con Gesù ne viene determinata la vita. E’ il rapporto affettivo con il destino ultimo della realtà che fa vivere. “Hai detto bene: non ho marito; infatti hai avuto cinque mariti e quello che hai adesso non è tuo marito. In questo hai detto il vero” (Gv 4, 18-19). Nel dire ciò Gesù consegna la donna alla verità di se stessa, non per umiliarla, ma per portarla a prendere coscienza che la vita non si svolge alla superficie dei legami del momento, ma nella fedeltà dei legami che tengono in vita. Il dialogo che Gesù instaura con la donna di Samaria – che si trova ad essere doppiamente esclusa, sia perché donna, sia perché samaritana – è un dialogo di reintegrazione dell’umano che conduce alla scoperta che la verità dell’uomo è il rapporto affettivo con il Cristo. Egli deve scendere nella profondità del pozzo del suo cuore perché la donna possa capire che solo Lui può colmare l’attesa che porta in sé. Alla fine del percorso intimo, che Gesù mediante il dialogo con lei, le fa fare, la donna diventa testimone di avere ritrovato il gusto della vita nell’incontro con “quell’uomo che gli ha detto tutto quello che aveva fatto”, che cioè l’ha riportata alla verità di sé. E questa verità è la scoperta di Dio in noi.
2. L’acqua viva
La vera stranezza sta nel fatto che è Gesù a chiedere dell’acqua, mentre dovrebbe essere il contrario: è il paradosso di un Dio che si fa bisognoso e mendicante dell’uomo: “Se tu sapessi chi è colui che ti dice: ‘Dammi da bere’, saresti tu a chiedergliene ed egli ti avrebbe dato acqua viva” (Gv 4,10): in queste parole sta la novità assoluta della rivelazione. Lo stupore che s’irraggia dalla rivelazione cristiana è che Dio si avvicina all’uomo e si preoccupa di lui, mentre la logica delle cose suggerisce il contrario. E’ la meraviglia di un Dio che chiede per dare. “Deus sitit sitiri” (S. Gregorio Nazianzeno nella traduzione latina del testo del Migne): Dio ha sete che si abbia sete di Lui. C’è un desiderio dell’uomo di Dio, ma c’è anche un desiderio di Dio dell’uomo. Non solo l’uomo ha nostalgia di Dio; anche Dio ha nostalgia dell’uomo. La donna è aperta all’offerta della possibilità che Gesù gli offre, anche se è piuttosto incredula poiché non ne vede il come possa avvenire ciò che quello sconosciuto giudeo. Mentre l’acqua del pozzo disseta la sete del momento, l’acqua della grazia è invece un’acqua “che zampilla come sorgente per la vita eterna”. L’acqua viva è una metafora che s’aggiunge a quella della “vita nuova” nel dialogo con Nicodemo. Là si intendeva dire che il soprannaturale comunicato implica una “rigenerazione nello Spirito” che introduce il credente come un neonato nel Regno di Dio. Qui, il tema è prolungato: entrare in relazione con il soprannaturale non implica solo uno stato iniziale, un essere generati, ma una nascita continua, in modo che tutta l’esistenza sia alimentata alle sorgenti del rapporto con Gesù: L’acqua viva di cui parla Gesù è il segno della rinascita nello Spirito: è il rapporto di grazia con l’affetto di Gesù verso di noi. E’ il riconoscimento di quest’affetto in noi che ci fa vivere.
3. Il vero culto: adorare in spirito e verità, ovvero riconoscere l’amore di Dio
L’affetto con cui Gesù si lega all’uomo introduce a capire l’amore del Padre. “E’ arrivato il momento, ed è questo …”, in cui il legame con Dio non avviene con un movimento dal basso (uomo) verso l’alto (Dio), ma inverso: è Dio che si china verso l’uomo e lo investe della sua agape, iscrivendo in lui il suo soffio (pneuma – spirito). Questo nuovo culto è stato spiegato nel capitolo di Nicodemo. [14]E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell’uomo, [15]perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna». [16]Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna. Il culto “in spirito e verità” del discepolo si esercita nel vedere/riconoscere l’amore di Dio verso il mondo portato in evidenza nella croce del Figlio. Mentre, nella cultura religiosa umana, Dio non può affermarsi se non nella modalità del dominio, la verità di Dio resasi evidente in Cristo sconvolge quest’immagine. Dio si manifesta attraverso l’impotenza di Gesù di fronte al tribunale della storia. La verità di Dio che emerge dalla Croce del Figlio assume la figura dell’amore che preferisce essere equivocato come impotenza pur di non trasformarsi in dominio. Colui che si imbatte nella croce e morte di Gesù è costretto a prendere una decisione pro o contro l’immagine di questo Dio di Gesù Cristo, che è un Dio amante dell’uomo. Un Dio che si concede e si mostra nella forma di una incondizionata dedizione in modo tale che l’uomo ne pre-senta l’affidabilità e si conceda nella fede. Esercitare attraverso lo Spirito la fede in questo Dio che ci ama è il culto nuovo che il Padre si attende dall’uomo. Lo si può fare lasciandoci trascinare nella forza attraente dello Spirito che “magnetizza” il nostro affetto con l’amore e ci fa incontrare quale Messia che si rivela alla donna: “[Il Messia] sono io che parlo con te” (Gv 4, 26).
4. La fede genera la missione
Giovanni si manifesta abile scenografo con un improvviso contro-movimento di personaggi: i discepoli ritornano da Sicar e la samaritana se ne ritorna in fretta al villaggio. Il cambio di scena dà una svolta al racconto e serve per introdurre il tema missionario, che già era come sottofondo della pericope della samaritana. Ora viene svolto apertamente. Il procedimento nasce ancora una volta da un dialogo di incomprensione. I discepoli sono preoccupati delle spese che hanno fatto nel villaggio e si meravigliano che Gesù abbia perso d’improvviso l’appetito e fanno ipotesi banali (“v. 33: I discepoli si domandavano l’un l’altro: «Qualcuno forse gli ha portato da mangiare?»). Gesù ha conquistato al Regno una persona e sta, attraverso di lei, per raggiungere tutto un villaggio di stranieri; ma per loro, che erano assenti, non è successo niente. Attestati sul cibo terreno e sulle loro convenzioni, i discepoli non sospettano in Gesù la presenza di un’altra fame e di un’altra ricerca. Gesù approfitta di questa incomprensione per annunciare il punto più alto della rivelazione circa la sua persona: “Mio cibo è fare la volontà di Dio” (v. 34). Il Figlio, l’eternamente amato, la pura accoglienza dell’amore, insegna che divino non è solo il dare ma anche il ricevere, mostrando che la vita autentica è “esistenza ricevuta”, ricevendo se se stesso dalla volontà del Padre. Ma qual è questa volontà? Il seguito del racconto lo dice con flash tratti dalla natura e da proverbi popolari: i campi sotto il sole di mezzogiorno e l’arrivo dei samaritani, la messe pronta, è ora di mietere: e cioè annunciare che le barriere del giudaismo sono crollate. L’ansia della missione è ben evidenziata dalla differenza fra le leggi che regolano l’agricoltura terrena (quattro mesi fra la semina e il raccolto) e l’azione missionaria, per la quale i campi sono da subito maturi. E i discepoli sono chiamati a essere partecipi a questa missione di Gesù.