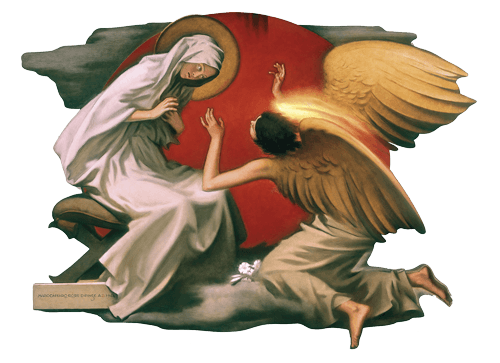L’invocazione di “Padre” senza altre aggiunte, dà il tono a tutta la preghiera, la determina in termini assoluti ed è più efficace della versione di Matteo (6, 9-13), perché descrive la natura di Dio in sé. La struttura interna di Dio è di essere “padre”, cioè sorgente che si espande. Questa parola è riferita a Dio circa 180 volte nei quattro evangelisti, mentre soltanto 15 volte in tutto l’ Antico Testamento. Tali numeri rivelano che la paternità di Dio è al centro della rivelazione evangelica.
Il v.13, poi, lascia intendere che poter chiamare Dio con questo nome è possibile perché dal Padre è stato riversato su di noi il dono del suo Spirito, lo Spirito del Figlio. E’ grazie a quest’effusione in noi che possiamo riconoscere in Dio “il” Padre (Rom 5, 5; 8, 26). E’ vero che dietro l’immagine del padre, proiettata su Dio, potrebbe nascondersi l’immagine del Dio – padrone autoritario che tutela sacralmente tutti coloro che comandano sugli altri; ma non è il caso del Padre dei cieli, il quale condivide la sua natura con il Figlio e lo Spirito. Dicendo che è Padre che si dona nel Figlio attraverso lo Spirito, si enuncia che la sua struttura intima di essere non è il potere, ma l’amore. Perciò l’immagine del padre deve essere commisurata non sul nostro risentimento verso l’autorità come limite della nostra libertà, ma sull’immagine neotestamentaria che ci espone un Padre che è donazione di sé nel Figlio e nello Spirito. La preghiera del discepolo è dunque una preghiera che introduce sempre in un clima di comunione. Se diciamo “padre” necessariamente alludiamo ad una famiglia, famiglia e comunione divina, in cui il padre è la sorgente ed il Figlio ricettacolo dove si travasa l’amore dello Spirito. Famiglia al cui interno, noi figli nel Figlio, abbiamo un posto ed una voce.