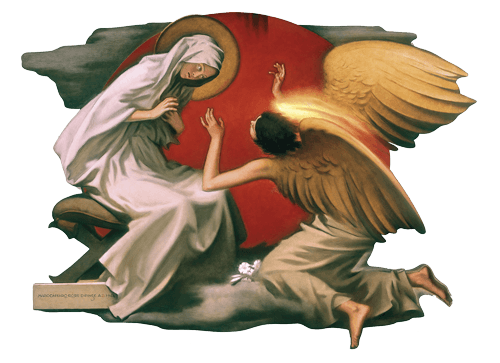4° incontro con la Parola guidato da P. Antonello Erminio, in Casa Madre dalle ore 15 alle 17,30.
4° incontro con la Parola guidato da P. Antonello Erminio, in Casa Madre dalle ore 15 alle 17,30.
Tema: L’inferno e la dannazione “eterna”: deserto degli affetti
Poi il figlio dell’uomo dirà anche a quelli che saranno alla sinistra: «Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato». Anch’essi allora risponderanno: «Signore, quando ti abbiamo visto affamato o assetato o straniero o nudo o malato o in carcere, e non ti abbiamo servito?». Allora egli risponderà loro: «In verità io vi dico: tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli, non l’avete fatto a me». E se ne andranno al supplizio eterno (Mt 25).
La sobrietà della Scrittura e del Magistero sull’inferno non è riuscita ad impedire ad un vero esercito di predicatori, di teologi, soprattutto nel Seicento e nel Settecento, di lasciarci interi tomi colmi di dissertazioni sull’inferno, così precisi da sembrare il resoconto di qualche visita guidata. Sanno tutto: numero dei vani, clima, viabilità … E tutti noi abbiamo perlomeno dato una sbirciata ai testi del nostro padre Dante. Nulla ha impedito dunque a legioni di predicatori di infiorare il discorso su questa alternativa certo radicale con un florilegio di immagini e deduzioni fantasiose. Su questo tema è necessario sfrondare tanta immaginazione e ritornare ai dati rivelati nella loro immediatezza.
L’esistenza dell’inferno è ben attestata nella Rivelazione. Sono troppo i passaggi evangelici, ben inseriti nel loro contesto e nella predicazione del Regno da parte di Gesù, per poter negare la presenza dell’inferno. Il discorso sull’inferno ha occupato nell’annuncio di Gesù un posto significativo; e la cosa è rinforzata dal fatto che è proprio Lui a parlarne, Lui che più di ogni altro ha avuto compassione degli uomini ed ha parlato della misericordia di Dio.
Al tempo di Gesù quest’idea di punizione nel fuoco da cui non si può ritornare doveva essere abbastanza popolare come si può constatare dalla parabola di Lazzaro e del ricco epulone (Lc 16, 19-31). Gesù riprende il termine “Geenna”, ormai spogliato del significato topografico, per indicare la punizione finale. Viene usato una dozzina di volte nei Vangeli (Mt 5, 29-30; 10, 28; 23, 15. 33; Mc 9, 43-48; Lc 12, 5). Il fuoco è presente soprattutto in Mt 13, 42. 50 (“la fornace di fuoco”) insieme al pianto e allo “stridore di denti”; il fuoco è definito “eterno” in Mt 18, 8; 25, 41; e “inestinguibile” in Mc 9, 43. 48. Altre volte si parla di “tenebre eterne” (Mt 8, 12; 22, 13; 25, 30) e di “tormenti” (Lc 16, 23-28). L’Apocalisse, alludendo alla fine di Sodoma e Gomorra, preferisce parlare di “lago di fuoco e di zolfo” (Ap 14, 10; 19, 20; 20, 10) e anche di “abisso” (Ap 20, 3). A questa serie di testi andrebbero aggiunti anche quelli che esprimono la possibilità dell’uomo di chiudersi completamente a Dio. E’ la bestemmia contro lo Spirito che “non sarà perdonata né in questo secolo, né in quello futuro” (Mt 12, 32; cf Lc 12,10): è “il peccato che conduce alla morte” per il quale è inutile pregare (1 Gv 5, 16-17). Per il NT esiste dunque la concreta possibilità che l’uomo si rinchiuda totalmente alla grazia e, con la sua libertà, non conceda nemmeno uno spiraglio alla grazia finendo per collocarsi nella situazione di un “peccato imperdonabile”.
Qual è allora il significato che Gesù attribuisce all’inferno?
Possiamo dire che l’inferno è l’oscuro contrappunto che ricorda la serietà della chiamata che Gesù fa di convertirsi al Regno che viene. Le parole di Gesù destano la consapevolezza che di fronte al Regno si gioca “il tutto”: o la salvezza o la dannazione. Gesù però si rifiuta di soddisfare la curiosità dei discepoli che lo interrogano se sono pochi quelli si salvano. Li richiama invece a rendersi conto della loro responsabilità: “Sforzatevi di entrare nel regno di Dio per la porta stretta” (Mt 7, 13= Lc 13, 24).
L’inferno è una verità di fede
- La verità di fede dell’inferno non è semplice da esprimere. Occorre essere cauti e prudenti nell’evitare di fare affermazioni che non sono in linea con la fede. Per parlare di inferno occorre partire da una verità centrale della fede: Dio ha mandato il suo Figlio perché tutti, legandosi in unità con Lui, accedano alla felicità eterna del paradiso. Pertanto la minaccia dell’inferno non è da mettere sullo stesso piano della salvezza offerta da Dio ad ogni uomo in Cristo. L’esistenza umana non è posizionata su un bivio con una uguale possibilità di scegliere: o la salvezza o la dannazione. Da parte sua, Dio non destina nessuno alla condanna e all’infelicità eterne. Se l’uomo si sottrae all’influsso salvifico, lo fa usando la sua libertà contro la volontà di Dio. Possiamo dire che la salvezza è un evento a portata di mano di tutti, mentre la dannazione è solo una possibilità basata sulla libertà umana di chi si rifiuta di accogliere la salvezza. Perciò dannazione e salvezza non sono simmetriche, e non vanno poste sullo stesso piano.
2. Consequenziale a questo primo punto sta l’affermazione che la possibilità dell’inferno salvaguarda la libertà umana. Perché, se si negasse la possibilità della dannazione e l’inferno, e si postulasse per l’uomo soltanto un esito di salvezza, non ci sarebbe più differenza tra l’impegnare se stessi per Dio o contro Dio, poiché in entrambi i casi si otterrebbe il medesimo risultato: alla fine resterebbe sostanzialmente impunito il male volontario e la sopraffazione resterebbe senza riscatto.
3. L’inferno esiste non perché Dio voglia punire le sue creature, ma perché la creature hanno la possibilità di chiudersi liberamente all’amore di Dio. E da parte di Dio, l’inferno esiste perché ama la libertà dell’uomo fino all’estremo, cioè fino ad accettare persino che la sua creatura lo rifiuti. L’Amore che Dio è non può, per sua struttura intrinseca, imporsi alle nostre libertà: se lo facesse contraddirebbe la sua natura di essere l’amore, poiché non si dà amore là dove c’è costrizione.
Come può Dio, se è giusto, dare una “punizione eterna” per peccati che, per quanto grandi e liberamente commessi, sono compiuti da persone limitate?
L’uomo è condizionato dal male che lo circonda e dalla sua intrinseca debolezza: come può Dio, se è veramente giusto, essere così spietato da dannare per sempre un essere umano per colpe che sono sempre compiute da un essere finito e condizionato? La pena non deve essere commisurata alla colpa?
Questa obiezione si basa su un equivoco. L’inferno non è una “pena vendicativa”, comminata cioè da un tribunale, a scopo di parificare punitivamente il danno commesso con una riparazione adeguata. In questo caso si dovrebbe giustamente rispettare il criterio di proporzionalità rispetto alla colpa. In realtà però la condanna non è una pena che viene inflitta da Dio; al contrario, è l’uomo che si rifiuta di concedersi all’amore di Dio. Il fatto è che chi si danna è perché decide di opporsi a Dio con una scelta definitiva fino all’ultimo istante in cui è in grado di esercitare una coscienza libera.
Qual è la natura dell’inferno?
La fede cristiana non spera di guadagnarsi il paradiso e non si lascia terrorizzare dall’inferno, bensì ha la ferma certezza che Dio è “braccia aperte” per ognuno; e perciò chi ha fede confida di poter essere accolto nella comunione con Dio in Gesù Risorto e, insieme, con tutte le forme di affetto che hanno costituito la sua storia e la vicenda umana universale. Chi spera sa che il Dio della vita può e, secondo la parola di Gesù lo farà, dare la vita oltre la morte perché il suo cuore è pienamente radicato nella certezza dell’amore di Dio. In questa prospettiva l’inferno non è una punizione di Dio, ma una creazione dell’uomo. Dio non ha fatto l’inferno. L’inferno lo fa l’uomo quando rifiuta totalmente l’amore di Dio e la carità verso i fratelli. Gesù per spiegare la condizione di colui che si danna ha fatto ricorso soprattutto al concetto di esclusione. Nella parabola delle vergini: “La porta fu chiusa” (Mt 25, 10). Nella parabola dei talenti, al servo che non ha fatto fruttare il talento per paura: “gettatelo fuori”. Nel giudizio alla fine della storia: “Via, lontano da me maledetti” (Mt 25, 41). Seguendo il filo di queste immagini possiamo affermare che Gesù non fa che confermare l’autoesclusione di non voler entrare in relazione con il Dio dell’amore. Quell’amore che egli ci ha chiesto di avere verso il fratello più povero ed escluso. Gesù conosce fino in fondo il cuore umano. Egli sa che è fatto per la felicità e che la felicità sgorga da un rapporto riuscito con l’Eterna Comunione divina e con gli altri. E per aiutare a comprendere che questo è il tessuto intimo di tutta la creazione, egli si è inabissato nell’avventura umana. Si è legato ad ogni uomo possa trovare la via per entrare in una relazione vitale con il Padre (Gv 14, 9-11). Ora lo stato di dannazione consiste nell’isolarsi su se stesso, facendo illusoriamente di sé “il tutto” e negandosi a una relazione buona con Dio e con gli altri. Chi ha scelto se stesso, alla fine ottiene solo se stesso. L’inferno è la pietrificazione dell’Io. Dante significativamente ne descrive la parte più profonda come un lago ghiacciato.
Chi non ha conosciuto Cristo può salvarsi?
La cura del prossimo è scritta nella struttura intrinseca dell’uomo, nella sua coscienza: è la legge conoscibile da chiunque si osservi nella propria coscienza umana (cf Mt 25). Esiste dunque una via alla portata di tutti gli uomini di buona volontà per raggiungere la salvezza ed è il più umano degli atteggiamenti, che è di stare compassionevolmente di fronte a un essere che abbia bisogno. Il motivo teologico è che il Cristo si è identificato con il più povero degli uomini: e oggettivamente, al di là di quanto una persona possa soggettivamente essere cosciente, servire il povero è servire Cristo e portare in sé un riflesso della Carità divina che vive nel mistero di Dio. Questo apre la via alla salvezza. Il venire meno alla legge interiore di essere solidali verso l’altro che vive accanto a sé pone oggettivamente in una condizione di dannazione; ed inversamente venire incontro ai fratelli più poveri è una possibilità che apre a tutti la speranza della salvezza.
La posizione del cristiano: “sperare per tutti”
Nessuno può dire che non c’è l’inferno. Nessuno può dire chi c’è, né se c’è qualcuno all’inferno. Semplicemente non sappiamo se qualche essere raggiunga la situazione di totale chiusura alla grazia. Una cosa è certa però: che la Rivelazione ci parla apertamente dell’Inferno. Ed è altrettanto chiaro che, se questa drammatica possibilità non ci fosse, la libertà umana sarebbe una parola vuota. La posizione del cristiano è quella di chi, fidandosi della misericordia di Dio, spera perché tutti si possano salvare da questa terribile possibilità H. U. Balthasar aveva questa posizione. Alla fine della vita, in un intervista, di fronte ad alcuni amici che erano perplessi su questo suo pensiero, disse “Si dovrebbe capire che io non voglio sapere qualcosa di più di quello che insegna la Scrittura; io non pretendo di sapere nulla “prima” del giudizio di Dio; io non sono certo di niente di quello che appartiene solo al segreto di Dio. Io voglio solo poter sperare, avere il diritto di sperare, voglio che sia lecito “sperare per tutti”. Sono altri che vogliono essere certi, certi che ci siano dei dannati, certi che l’inferno sia pieno, certi che Dio non possa salvare tutti. Se io pretendessi di essere certo dell’esito dell’ultimo giudizio di Dio sarei eretico, ma io voglio solo poter sperare, poter pregare per la salvezza di tutti, ritenendo possibile che Dio esaudisca le preghiere della Chiesa”.
P. Antonello Erminio
Ascolta l’audio della meditazione
Parte 1:
Parte 2: