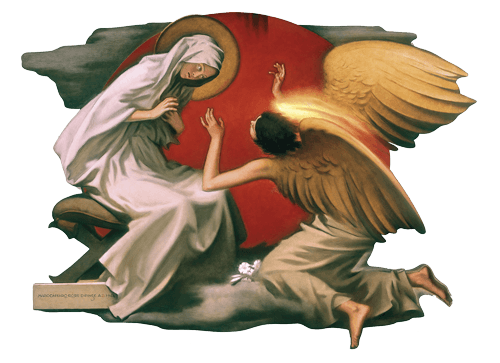Sabato 17 gennaio 
1. Uno sguardo sul mondo da evangelizzare
“ … la maggior parte degli uomini e delle donne del nostro tempo vivono una quotidiana precarietà, con conseguenze funeste. Aumentano alcune patologie. Il timore e la disperazione si impadroniscono del cuore di numerose persone, persino nei cosiddetti paesi ricchi. La gioia di vivere frequentemente si spegne, crescono la mancanza di rispetto e la violenza, l’iniquità diventa sempre più evidente (EG 52).
a) Siamo entrati nella cultura dello “scarto” e dell’esclusione. Oggi tutto entra nel gioco della competitività e della legge del più forte, dove il potente mangia il più debole. Come conseguenza di questa situazione, grandi masse di popolazione si vedono escluse ed emarginate: senza lavoro, senza prospettive, senza vie di uscita. Si considera l’essere umano in se stesso come un bene di consumo, che si può usare e poi gettare. Abbiamo dato inizio alla cultura dello “scarto” che, addirittura, viene promossa. Non si tratta più semplicemente del fenomeno dello sfruttamento e dell’oppressione, ma di qualcosa di inedito: con l’esclusione resta colpita, nella sua stessa radice, l’appartenenza alla società in cui si vive, dal momento che in essa non si sta nei bassifondi, nella periferia, o senza potere, bensì si sta fuori. Gli esclusi non sono “sfruttati” ma rifiuti, “avanzi” (EG 53).
b) Anestesia di fronte al grido di dolore degli altri. “Quasi senza accorgercene, diventiamo incapaci di provare compassione dinanzi al grido di dolore degli altri, non piangiamo più davanti al dramma degli altri né ci interessa curarci di loro, come se tutto fosse una responsabilità a noi estranea che non ci compete. La cultura del benessere ci anestetizza” (EG 54).
c) Feticismo del denaro ed economia senza volto. “… abbiamo stabilito con il denaro una relazione in cui accettiamo pacificamente il suo predomino su di noi e sulle nostre società. La crisi finanziaria che attraversiamo ci fa dimenticare che alla sua origine vi è una profonda crisi antropologica: la negazione del primato dell’essere umano! Abbiamo creato nuovi idoli (EG 55). La brama del potere e dell’avere non conosce limiti. In questo sistema, che tende a fagocitare tutto al fine di accrescere i benefici, qualunque cosa che sia fragile, come l’ambiente, rimane indifesa rispetto agli interessi del mercato divinizzato, trasformati in regola assoluta. (EG 57). Il denaro deve servire e non governare! (EG 58).
d) Prevalere dell’apparire sull’essere. “Nella cultura dominante, il primo posto è occupato da ciò che è esteriore, immediato, visibile, veloce, superficiale, provvisorio. Il reale cede il posto all’apparenza” (EG 62). “riconosciamo che, se parte della nostra gente battezzata non sperimenta la propria appartenenza alla Chiesa, ciò si deve anche … a un atteggiamento burocratico per rispondere ai problemi … In molte parti c’è un predominio dell’aspetto amministrativo su quello pastorale” (EG 63).
e) Assottigliarsi dei legami, eppure i legami sono garanzie di affetti significativi. “La famiglia attraversa una crisi culturale profonda, come tutte le comunità e i legami sociali. Nel caso della famiglia, la fragilità dei legami diventa particolarmente grave perché si tratta della cellula fondamentale della società, del luogo dove si impara a convivere nella differenza e ad appartenere ad altri e dove i genitori trasmettono la fede ai figli. Il matrimonio tende ad essere visto come una mera forma di gratificazione affettiva che può costituirsi in qualsiasi modo e modificarsi secondo la sensibilità di ognuno. Ma il contributo indispensabile del matrimonio alla società supera il livello dell’emotività e delle necessità contingenti della coppia: il matrimonio non nasce dal sentimento amoroso, effimero per definizione, ma dalla profondità dell’impegno assunto dagli sposi che accettano di entrare in una comunione di vita totale. L’individualismo postmoderno e globalizzato favorisce uno stile di vita che indebolisce lo sviluppo e la stabilità dei legami tra le persone, e che snatura i vincoli familiari. L’azione pastorale deve mostrare ancora meglio che la relazione con il Padre dei cieli esige e incoraggia una comunione che guarisca, promuova e rafforzi i legami interpersonali. Mentre nel mondo, specialmente in alcuni Paesi, riappaiono diverse forme di guerre e scontri, noi cristiani insistiamo nella proposta di riconoscere l’altro, di sanare le ferite, di costruire ponti, stringere relazioni e aiutarci «a portare i pesi gli uni degli altri» (Gal 6,2). D’altra parte, oggi nascono molte forme di associazione per la difesa di diritti e per il raggiungimento di nobili obiettivi. In tal modo si manifesta una sete di partecipazione di numerosi cittadini che vogliono essere costruttori del progresso sociale e culturale (EG 66-67).
f) Grandi masse nelle città aspettano una nuova evangelizzazione. “… negli ultimi decenni, si è prodotta una rottura nella trasmissione generazionale della fede cristiana nel popolo cattolico. È innegabile che molti si sentono delusi e cessano di identificarsi con la tradizione cattolica, che aumentano i genitori che non battezzano i figli e non insegnano loro a pregare, e che c’è un certo esodo verso altre comunità di fede. Alcune cause di questa rottura sono: la mancanza di spazi di dialogo in famiglia, l’influsso dei mezzi di comunicazione, il soggettivismo relativista, il consumismo sfrenato stimolato dal mercato, la mancanza di accompagnamento pastorale dei più poveri, l’assenza di un’accoglienza cordiale nelle nostre istituzioni e la nostra difficoltà di ricreare l’adesione mistica della fede in uno scenario religioso plurale. … Abbiamo bisogno di riconoscere la città a partire da uno sguardo contemplativo, ossia uno sguardo di fede che scopra quel Dio che abita nelle sue case, nelle sue strade, nelle sue piazze. La presenza di Dio accompagna la ricerca sincera che persone e gruppi compiono per trovare appoggio e senso alla loro vita. Egli vive tra i cittadini promuovendo la solidarietà, la fraternità, il desiderio di bene, di verità, di giustizia. Dio non si nasconde a coloro che lo cercano con cuore sincero, sebbene lo facciano a tentoni, in modo impreciso e diffuso. … di solito implica un profondo senso religioso. Dobbiamo contemplarlo per ottenere un dialogo come quello che il Signore realizzò con la Samaritana, che cercava di saziare la sua sete.” (EG 70-73).
2. Una spiritualità missionaria
“Si rende necessaria un’evangelizzazione che illumini i nuovi modi di relazionarsi con Dio, con gli altri e con l’ambiente. È necessario arrivare là dove si formano i nuovi racconti e paradigmi, raggiungere con la Parola di Gesù i nuclei più profondi dell’anima delle città”. (EG 74) Come figli di questa epoca, tutti siamo in qualche modo sotto l’influsso della cultura attuale globalizzata, che, pur presentandoci valori e nuove possibilità, può anche limitarci, condizionarci e persino farci ammalare. Riconosco che abbiamo bisogno di creare spazi adatti a motivare e risanare: luoghi in cui rigenerare la propria fede in Gesù crocifisso e risorto, in cui condividere le proprie domande più profonde e le preoccupazioni del quotidiano…”. (EG 77).
3. Alcune tendenze dei credenti da cui guarire
Due sono i pericoli dei credenti nell’oggi: a) “La cultura mediatica e qualche ambiente intellettuale a volte trasmettono una marcata sfiducia nei confronti del messaggio della Chiesa, e un certo disincanto. Come conseguenza, molti [credenti], benché preghino, sviluppano una sorta di complesso di inferiorità, che li conduce a relativizzare o ad occultare la loro identità cristiana e le loro convinzioni. … si cade in una specie di ossessione per essere come tutti gli altri … e si sviluppa un relativismo pratico che consiste nel vivere come se Dio non esistesse ” (EG 79-80); b) “Invece di un dinamismo missionario nell’animo s’impadronisce un’accidia paralizzante. Il problema non sempre è l’eccesso di attività, ma soprattutto sono le attività vissute male, senza le motivazioni adeguate, senza una spiritualità che permei l’azione e la renda desiderabile. Da qui deriva che i doveri stanchino più di quanto sia ragionevole, e a volte facciano ammalare. Non si tratta di una fatica serena, ma tesa, pesante, insoddisfatta e, in definitiva, non accettata. … Così prende forma la più grande minaccia, che «è il grigio pragmatismo della vita quotidiana della Chiesa, nel quale tutto apparentemente procede nella normalità, mentre in realtà la fede si va logorando e degenerando nella meschinità». Si sviluppa la psicologia della tomba, che poco a poco trasforma i cristiani in mummie da museo. (EG 81-83).
No al pessimismo sterile
La gioia del Vangelo è quella che niente e nessuno ci potrà mai togliere (Gv 16,22). I mali del nostro mondo – e quelli della Chiesa – non dovrebbero essere scuse per ridurre il nostro impegno e il nostro fervore. Consideriamoli come sfide per crescere. Inoltre, lo sguardo di fede è capace di riconoscere la luce che sempre lo Spirito Santo diffonde in mezzo all’oscurità, senza dimenticare che «dove abbondò il peccato, sovrabbondò la grazia» (Rm 5,20). La nostra fede è sfidata a intravedere il grano che cresce in mezzo della zizzania. Una delle tentazioni più serie che soffocano il fervore e l’audacia è il senso di sconfitta, che ci trasforma in pessimisti scontenti e disincantati dalla faccia scura. Nessuno può intraprendere una battaglia se in anticipo non confida pienamente nel trionfo. Anche se con la dolorosa consapevolezza delle proprie fragilità, bisogna andare avanti senza darsi per vinti, e ricordare quello che disse il Signore a san Paolo: «Ti basta la mia grazia; la forza infatti si manifesta pienamente nella debolezza» (2 Cor 12,9).