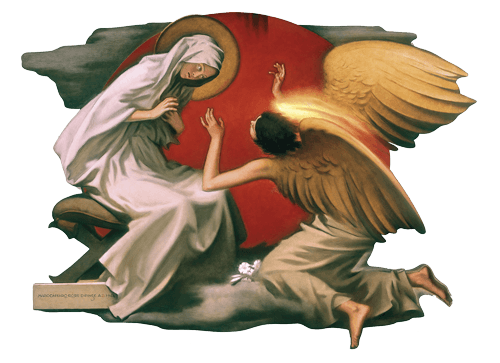In questa pagina troverai l’audio e il testo della prima meditazione tenuta da Padre Antonello Erminio domenica 24 novembre 2024.
In questa pagina troverai l’audio e il testo della prima meditazione tenuta da Padre Antonello Erminio domenica 24 novembre 2024.
Io credo in Dio Padre, creatore dell’universo e dell’uomo
audio: prima parte della meditazione
audio: seconda parte della meditazione
Premessa: la paternità di Dio non va dedotta dai nostri penseri
Che Dio sia Padre, e come lo sia, non dipende dalla nostra immaginazione. Nel definire la paternità di Dio non possiamo partire dal nostro pensiero; se lo facessimo, proietteremmo su di lui i nostri sentimenti. Se una persona avesse vissuto nella sua esperienza umana in una relazione buona di figliolanza verso suo padre o verso l’autorità in genere, rispecchierebbe in Dio questo suo vissuto positivo. Al contrario, se una persona avesse avuto rapporti difficili e complicati con suo padre terreno, potrebbe nutrire verso Dio sentimenti di collera, ribellione e rifiuto fino alla sua negazione. Un Dio-Padre di questo tipo, evidentemente, non ha che il peso della fantasia. Perciò, in una riflessione su Dio-Padre occorre essere critici circa la propria esperienza per non trasferirla su Dio. Il punto visivo corretto per capire qualcosa della paternità di Dio è la testimonianza di Gesù. E’ Gesù che ci rivela il volto interiore di Dio come paternità. Gesù però non ce lo rivela semplicemente come informazione. Ce lo mostra attraverso la sua persona e la sua storia umana.
1. Dio si fa vedere dal modo con cui Gesù ha vissuto umanamente il riferimento al Padre
Quando, alla fine del tempo trascorso con i discepoli, questi hanno capito quanto il Padre fosse il punto centrale di riferimento nella vita di Gesù, riassumono tutto il problema della loro esistenza dicendo: “Mostraci il Padre, e ci basta!” (Gv 14, 8). Filippo ha capito dal vivere accanto a Gesù che, per l’uomo, il rapporto con il Padre è tutto, ma non ha capito che proprio vivendo il rapporto con Gesù si entra nella famiglia di Dio e, quindi, si partecipa della paternità divina. Pertanto, Gesù gli risponde: “Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me, ha visto il Padre. Come puoi tu dire: Mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre ed il Padre è in me?” (Gv 14, 8-10). Dio, dunque, si dà a noi nell’esperienza vissuta da Gesù con il Padre: un’esperienza di intimità tale che Egli poteva dire: “Il Figlio da sé non può fare nulla se non ciò che vede fare dal Padre; e quello che il Padre Fa, anche il Figlio lo fa” (Gv 5, 19). Questo modo di darsi di Dio è l’unico modo per essere compreso dalla nostra umanità. Il trascendente ha forse un’altra maniera per dar notizia di sé che non sia quella di apparire come un fenomeno di questo mondo? Ora, poiché Dio ha voluto rivelarsi non poteva che farlo attraverso un evento umano riconoscibile dall’uomo. Dio nella sua paternità si è pertanto mostrato nella vita storica di Gesù. Senza la presenza di Gesù il velo che ci separa dal divino sarebbe rimasto impenetrabile. Ci saremmo trovati viandanti smarriti nel labirinto della vita con le nostre fantasie e i nostri pensieri su Dio. Invece Egli ci ha dato il Figlio, perché anche noi potessimo ritrovare la strada della sua casa paterna. Per avvicinarci alla paternità di Dio, dobbiamo aprirci un varco tra pregiudizi che possono agire sul nostro sentimento religioso, bonificando alcuni sentimenti vitali che l’ateismo ha seminato nella nostra cultura e che inconsapevolmente attecchiscono in ogni coscienza del mondo occidentale contemporaneo.
2. La pressione della cultura atea dell’epoca moderna sulla nostra coscienza
Vi è un pregiudizio di fondo che nasce da una visione distorta della religione, propagandata a piene mani dai tre “maestri del sospetto” dell’epoca moderna: Marx, Nietzsche e Freud. Per essi la religione è proiezione illusoria dei conflitti psichici della persona ed ideologia rispecchiante le contraddizioni sociali: Dio, di conseguenza, non è che il nome dato alle attese o delusioni umane e, come tale, non ha che un ruolo consolatorio per i deboli ed i fragili. “Le ideologie moderne – ha scritto Giovanni Paolo II– si incontrano al crocevia dell’autosufficienza dell’uomo, senza che alcuna di esse riesca a colmare la sete di assoluto che lo attanaglia”. Ponendo l’uomo come unico centro del reale, la modernità materalista ha immaginato il ruolo di Dio nel mondo come alienazione e, quindi, disturbo nel cammino di emancipazione dell’uomo. Il corollario di questa visione è “la morte di Dio”: affinché l’uomo possa essere se stesso, si deve eliminare Dio dalla sua coscienza. Dio non solo è inutile, poiché a spiegare il mondo ci pensa la scienza, ma è dannoso perché svolge un ruolo inibitorio verso l’uomo nel suo impegno nel mondo. Per i vari materialismi Dio non è “padre”, ma padrone. E quindi bisogna occultarne la presenza, perché sottrae il gusto del vivere, incombendo sulla libertà umana come restrizione. La conclusione che ne scaturisce è che, se si vuole costruire una società libera, si deve eliminare la figura del “padre” dalla coscienza umana. Gli slogans sessantottini inneggiavano ad “una società senza padri”. E Dio quale “Padre dei padri” era il primo a dover essere eliminato: “Uccidiamo il padre”. Questo tipo di pensieri di fatto ha generato in realtà una società piena di orfani, piombando in una forma adolescenziale generalizzata, dove al posto dell’avventura del rischio e della costruzione si va affermando un comodo maternage in cui rifugiarsi.
3. La paternità di Dio ci è rivelata dall’evento di Cristo
La fede cristologica ci prospetta un Dio profondamente rispettoso della nostra libertà. Un fine osservatore Sigrid Undset ha scritto: “Dio poteva obbligare gli uomini a seguire la via che aveva tracciato per loro, a obbedire come fanno le stelle. Ma egli si è fatto uomo e ha deposto la sua onnipotenza sull’uscio del cuore degli uomini. (…) L’onnipotenza che regge il cosmo mendica tra la folla delle anime umane, chiedendo l’elemosina di poter dare, di poter spartire le ricchezze misteriose del proprio essere divino”. Ed è proprio questa la convinzione fondamentale del Vangelo di Gesù. Dio – ci insegna Gesù – è un padre che condivide la sua ricchezza divina offrendola alla nostra umanità, non un padrone che, dominando sulle sue creature, le obbliga a riconoscerlo e ad inchinarsi davanti a lui.
4. La rivelazione di Gesù su Dio Padre
Nei vangeli Gesù chiama Dio con il nome di “Padre” non meno di 170 volte. Il punto, in ogni caso più pregnante e scandaloso, è l’invocazione “Abbà, Padre!”, riportata da Mc 14, 36 nella preghiera di Gesù nell’orto degli Ulivi, e che riecheggia nella preghiera dei primi cristiani (Gal 4, 6; Rom 8,15). Questa preghiera è assolutamente unica. E’ la prima volta che s’incontra l’invocazione a Dio-Padre a titolo individuale, da persona a persona, nell’ambiente palestinese ed è la prima volta che un giudeo si indirizza a Dio chiamandolo personalmente “Padre” in forma familiare. Gesù si indirizza a Dio come un bambino al suo papà. “Questo fatto senza precedenti in tutta la pietà giudaica, costituisce un tratto caratteristico della preghiera di Gesù. I giudei non avrebbero mai impiegato il termine Abbà nelle loro forme di preghiera. Dare questo titolo alla divina maestà sarebbe stato per essi una vera profanazione” (W. Marchel). In questo modo Gesù manifesta la coscienza di essere in relazione unica con il Padre, dal quale egli riceve ogni autorità e tutti i segreti, insieme con il potere di rivelare il Padre agli uomini: “Tutto mi è stato dato dal Padre mio; nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare” (Mt 11, 27). Ci viene così fatto intravedere qualcosa del mistero del Dio cristiano, che è Padre di Gesù e, attraverso la rivelazione di Gesù, anche “padre nostro”. Padre in due modalità differenti come sottolinea il Vangelo, perché altro è il modo con cui Gesù dice “Padre mio” e altro è quando invita a pregarlo dicendo “Padre nostro”. Da Figlio naturale nel primo caso, da figlio adottivo nel secondo caso. Anche noi, dunque, possiamo rivolgerci a Dio nel nome di Gesù, uniti a Lui, chiamandolo “padre”, poiché siamo stati adottati come “figli” da Dio. Non è la filiazione determinata semplicemente dal fatto di essere da lui creati, ma è il nuovo legame che l’umanità di Gesù, partecipe della nostra natura, instaura in noi. In lui, il Figlio, e nell’effusione del suo Spirito in noi, possiamo anche noi rivolgerci a Dio in un vincolo di figliolanza adottiva, pregandolo come Padre. “Avete ricevuto uno spirito da figli adottivi per mezzo del quale gridiamo: Abbà, Padre! Lo Spirito Santo stesso attesta al nostro spirito che siamo figli di Dio” (Rom 8, 15-16).
5. Assumere coscienza di essere figli di Dio
Si tratta, cioè di lasciarsi penetrare dallo spirito di figliolanza che caratterizza Gesù nella sua umanità. Gesù che “vive per il Padre” (Gv 6, 57) non esprime alcun infantilismo, con il quale voglia captare la benevolenza del Padre. Non cerca il Padre come alibi consolante. Né si rivolge a lui come immagine alienante, che tolga ogni responsabilità e fatica nel cammino dell’esistenza. Entra invece nella logica concreta e drammatica della storia umana, e mostra che ogni uomo può vivere se interiorizza il padre e vive da figlio che ama il Padre. Non c’è nulla, proprio nulla nel legame tra Gesù e il Padre che denunci la gelosia e la rivalità con cui la psicanalisi ha caratterizzato il divenire maturo dell’uomo. Al contrario vivere nella paternità di Dio dà quella sicurezza di un destino buono che nessuno può darsi da solo. Proprio perché è Padre Dio ci accompagna nel cammino tortuoso della vita.
6. Dio nella sua paternità infinita crea il non-divino
Dio – ci ha spiegato Gesù – si prende cura della sua creazione. Non vuole che si perda, ma la invita a partecipare della sua vita divina: “Dio ama tanto il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna” (cf Gv 3,16). Nella sua intima struttura Dio è padre perché la sua esistenza consiste nel generare altro da sé, il Figlio. Ma la sua paternità non si ferma qui. Egli ha deciso di creare il non-divino al di fuori di Sé. Oltre Sé non c’era niente e Dio ha avuto la potenza di allargare la propria vita nella materia, creando il mondo. Anzi si compiace di esso: “E Dio vide quanto aveva creato, ed ecco: era cosa molto buona!” (Gn 1, 3-31). E per non perdere questa sua creatura – che si è voluta distaccare da Lui – ha dato vita a una storia di salvezza avendo come centro restauratore il proprio Figlio, Crocifisso e Risorto. In Gesù Crocifisso e Risorto si vede l’amore paterno di Dio per l’uomo. E’ un amore che, pur di non essere equivocato come potere, si manifesta come debolezza, là sulla croce, in modo da poter essere riconosciuto nella sua natura di amore assoluto verso la creatura. Da questa visione scaturisce la convinzione di fede che il male che tanto scandalizza la nostra coscienza umana non è vincitore nel mondo, perché nella sua misteriosità Dio conduce la realtà secondo un disegno provvidenziale. Dio governa con la sua Provvidenza tutto ciò che ha creato.
7. Dio Padre provvidente e il sentimento di appartenere a Lui
La sollecitudine di Dio Provvidente è concreta e immediata: si prende cura di tutto, delle piccole cose sino ai grandi eventi della storia e del mondo. Gesù introduce il discepolo a un abbandono totale al Padre, perché solo in tale appartenenza l’uomo diventa se stesso. E’ un rapporto che, in quanto riconosciuto e vissuto, realizza l’anelito al divino dell’uomo. Questa religiosità vissuta è il compimento dell’amore, perché amare vuol dire appartenere. Più si appartiene a Dio come a Padre e più si è rigenerati dalla profondità ultima di se stessi. “Per la vostra vita non affannatevi di quello che mangerete o berrete, e neanche per il vostro corpo, di quello che indosserete; la vita forse non vale più del cibo e il corpo più del vestito? [26] Guardate gli uccelli del cielo: non seminano, né mietono, né ammassano nei granai; eppure, il Padre vostro celeste li nutre. Non contate voi forse più di loro? [27] E chi di voi, per quanto si dia da fare, può aggiungere un’ora sola alla sua vita? [28]E perché vi affannate per il vestito? Osservate come crescono i gigli del campo: non lavorano e non filano. [29] Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. [30] Ora se Dio veste così l’erba del campo, che oggi c’è e domani verrà gettata nel forno, non farà assai più per voi, gente di poca fede? [31] Non affannatevi dunque dicendo: Che cosa mangeremo? Che cosa berremo? Che cosa indosseremo? [32] Di tutte queste cose si preoccupano i pagani; il Padre vostro celeste, infatti, sa che ne avete bisogno” (Mt, 6, 25-32). La religiosità cristiana in Dio-Padre realizza la relazione essenziale che dà consistenza all’uomo. Senza tale relazione, l’uomo finisce per diventare schiavo delle sue reazioni emotive, che solcano la sua sensibilità e che lo rendono violento verso di sé o verso gli altri, oppure tiranneggiato da chi è più potente. Appartenere alla paternità di Dio rappresenta la possibilità di esperimentarsi come persona, cioè come soggetto inconfondibile di fronte allo sviluppo del mondo. Il rapporto con cui Gesù introduce al Padre è la segreta energia che dà respiro alla persona, liberandola dalla sua volontà vissuta come anarchia o capriccio. In tal modo, dipendendo direttamente da Dio Padre, l’uomo si radica sul principio che gli dà origine e che lo attende come fine. In tal modo il sentimento di vita più profondo del cristiano è di sentirsi appartenente alla paternità di Dio, per cui, abbandonato alla sua volontà, si lascia condurre nelle circostanze concrete dell’esistenza.
8. Gesù insegna a pregare il Padre.
Quando Gesù insegna il Padre nostro comunica ai discepoli il sentimento di una preghiera fatta di confidenza in Dio. Questa preghiera ha un tessuto emotivo di fondo che va al di là delle parole e che deve sempre essere tenuto presente per evitare che le parole siano devianti. Che cosa significa allora per noi vivere la preghiera del Padre Nostro? La preghiera ci pone nella familiarità con Dio. Ciò avviene quando l’uomo prova a stabilire una relazione con Dio in cui rinuncia a parlarGli e a porre domande; ed invece prova a sentire l’emozione di entrare in relazione con la radice di tutte le radici, con il principio di tutti i principi, con l’interrogativo e la fine di tutti gli interrogativi. Ed ecco questo è il momento che Dio attende gelosamente perché finalmente l’uomo la smette di identificarLo con questo o con quell’altro, e semplicemente si consegna a Lui come Padre. E’ a questo punto che l’uomo si sente generato e amato, e Dio diventa compagnia alla sua solitudine e dà alla sua persona la letizia di un rapporto insostituibile e libero. Ecco, allora la preghiera è il riconoscimento filiale che Dio che sta conducendo la sua esistenza: io sono Tu, che mi crei nell’istante che passa. La vita si esprime come la coscienza di questo rapporto di esistenza con Colui che la genera e la preghiera è accorgersi che in “questo” preciso momento che la propria vita gli “è data”. Pertanto, i sentimenti della preghiera cristiana sono lo stupore, la gratitudine, la soggezione amorosa, la serenità. Di questi sentimenti s’intesse quel dialogo silenzioso che può costituire la trama delle giornate vissute nella lieta consapevolezza di “essere figli”. Tutto questo non matura e non cresce in noi spontaneamente. Anzi in noi ci sono dei picchi di esaltazione, ma poi tende a subentrare una grande dimenticanza. Allora il cuore della preghiera è la domanda costante. Lo ripete Gesù nell’insegnamento ai discepoli: “Pregate sempre senza stancarvi”.
Il Padre darà quanto gli abbisogna a chi domanda (Lc 11, 5-8)
[5] Poi aggiunse: “Se uno di voi ha un amico e va da lui a mezzanotte a dirgli: Amico, prestami tre pani, [6] perché è giunto da me un amico da un viaggio e non ho nulla da mettergli davanti; [7] e se quegli dall’interno gli risponde: Non m’importunare, la porta è gia chiusa e i miei bambini sono a letto con me, non posso alzarmi per darteli; [8]vi dico che, se anche non si alzerà a darglieli per amicizia, si alzerà a dargliene quanti gliene occorrono almeno per la sua insistenza.
Chi chiede riceve
[9] Ebbene io vi dico: Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. [10] Perché chi chiede ottiene, chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto. [11] Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pane, gli darà una pietra? O se gli chiede un pesce, gli darà al posto del pesce una serpe? [12]O se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione? [13] Se dunque voi, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro celeste darà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono!”.
In conclusione
La paternità di Dio è da una parte una verità consolante per l’esistenza umana, poiché questa non è abbandonata al caso ed all’incertezza. E’ in mani buone. E perciò la vita è al sicuro, perché la destinazione del suo camminare è un orizzonte di salvezza e di compimento dell’anelito di felicità del cuore. Ma questa paternità non è “molliccia”. Essa investe la nostra personale responsabilità. Mette in movimento la nostra libertà. Gesù non è venuto al mondo per dirci che c’è un Padre che si sostituisce al nostro lavoro, alla nostra libertà o per liberarci dalla prova. Egli è venuto al mondo per richiamarci al fondo di tutte le questioni. E’ venuto per richiamarci alla religiosità vera. Il problema del senso delle cose (la verità), il problema dell’uso delle cose (economia e lavoro), il problema dei rapporti umani (amore), il problema della convivenza civile (società e politica) mancano di giusta impostazione, e perciò generano sempre confusione nella storia del singolo e dell’umanità, nella misura in cui non si fondano sulla religiosità autentica, che è garantita dalla certezza che vi è un Padre dei cieli. Il ricorso a lui non è un gesto di magia. Il compito di Dio non è di risolvere i problemi umani, ma richiamare a quella posizione umana attraverso la quale è possibile risolverli. Sapere che la vita si svolge sotto lo sguardo di Dio, la rende migliore e più bella, perché non abbandonata a se stessa ed ai suoi capricci. Capirlo è una grazia.
P. Antonello Erminio