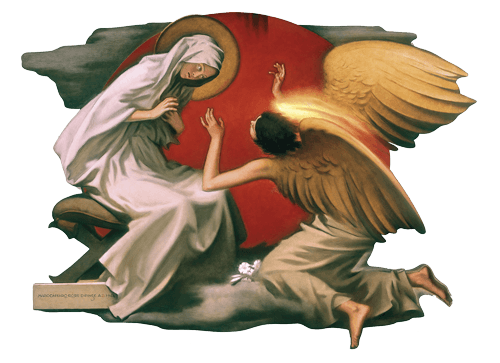Domenica 12 maggio 2024, nel salone di Casa Madre si è concluso il ciclo di “Incontri con la Parola” guidato da padre Antonello Erminio. Il tema di quest’ultima catechesi: L’inferno come possibilità della libertà umana. Qui di seguito, condividiamo l’audio e il testo scritto.
Domenica 12 maggio 2024, nel salone di Casa Madre si è concluso il ciclo di “Incontri con la Parola” guidato da padre Antonello Erminio. Il tema di quest’ultima catechesi: L’inferno come possibilità della libertà umana. Qui di seguito, condividiamo l’audio e il testo scritto.
Audio della prima parte
Audio della seconda parte
L’inferno come possibilità della libertà umana
Circa il nostro destino futuro siamo avvolti dal mistero. D’altra parte, anche nella nostra vita presente c’è sempre un velo che ne offusca la vista. Ma nella fede sappiamo che dietro a questo velo si nasconde il volto di un Padre che vuole personalmente ciascuno di noi alla vita. Di più, desidera che questa vita sia piena. Questa è la certezza che scaturisce dalla fede che Gesù ci ha comunicato con la sua vita:
“Sono venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza” (Gv 10,10). “Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me – dice Gesù – Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. … Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi” (Gv 14, 1-3).
Questo è l’oggetto proprio della fede cristiana circa il futuro di ogni uomo. Il centro della nostra fede è dunque che la storia personale e universale abbia un esito positivo, poiché ancorata nell’evento del Figlio di Dio che da sempre è connesso con la realtà della creazione e a favore di essa ha consegnato tutto se stesso fino alla morte di croce: “Avendo amato i suoi, li amò fino alla fine” (Gv 13, 1). Perciò la fede cristiana nutre la speranza per tutta la creazione di una destinazione di felicità eterna (paradiso). Ma proprio perché ogni essere creato nella libertà è chiamato a inserirsi in questo evento di salvezza, esiste anche la possibilità di un fallimento definitivo (Inferno), che è come lo sfondo oscuro nel quale l’uomo può sprofondare. Sul tema dell’inferno però è necessario sfrondare tanta immaginazione e ritornare ai dati rivelati nella loro immediatezza:
“La sobrietà della Scrittura e del Magistero sull’inferno non è riuscita ad impedire ad un vero esercito di predicatori, di fedeli pur mossi da rette intenzioni, di teologi, soprattutto nel Seicento e nel Settecento, di lasciarci interi tomi colmi di dissertazioni sull’inferno, così precisi da sembrare il resoconto di qualche visita guidata. Sanno tutto: numero dei vani, clima, viabilità … E tutti noi abbiamo perlomeno dato una sbirciata ai testi del nostro padre Dante. Nulla ha impedito dunque a legioni di predicatori di infiorare il discorso su questa alternativa certo radicale con un florilegio di immagini e deduzioni fantasiose” (Sequeri).
1. L’“inferno” nella Parola di Dio
L’inferno è una realtà di fede consegnataci nelle parole del Vangelo, il quale si serve di alcune immagini per descriverlo. La prima immagine è quella di esclusione (Mt 25, 1-13; Lc 14, 16-24); altra immagine ne descrive il dolore che risulta dal “fuoco” che distrugge (Mt 5,22; 13, 42; 18,8; Mc 9, 43. 48), accompagnato dall’“oscurità delle tenebre” (Mt, 812; 22, 13; 25,30) e da “pianto e stridore di denti” (Mt 8,12; 13, 42.45; 22, 13; 24, 51; 25, 30; Lc 13, 28). Queste figure descrivono il fallimento definitivo di una vita umana come esclusione dai rapporti che fanno vivere e cioè con Dio, con i fratelli e con tutte le creature. Tagliati fuori da ogni comunione con altri, l’inferno si presenta sostanzialmente come un irrigidimento nella capacità di amare. E poiché l’esperienza vitale dell’uomo è caratterizzata dall’amare e dall’essere amato, una simile esclusione è massimamente dolorosa. Questo dato della Rivelazione ci ammonisce che non possiamo prendere alla leggera la possibilità della perdizione. Tuttavia questa realtà va dialetticamente mitigata alla luce della volontà salvifica universale incentrata sulla missione del Figlio Incarnato: “Dio vuole che tutti gli uomini siano salvi” (1 Tim 2,4) e “Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui (Gv 3,17)”. Ora i dati scritturistici che ci consegnano que questa volontà di Dio sono preminenti, e prevale sulla possibilità della dannazione, e questo ci fa capire che Dio fa di tutto per avere accanto a Sé nella gioia eterna ogni uomo. Non destina quindi nessuno al fallimento, perché l’intimo desiderio di Gesù è che nessuno si perda come lui stesso ha detto: “Non ho perduto nessuno di quelli che mi hai dato” (Gv 18, 9). Per questo la dottrina sull’inferno non è contenuta negli antichi simboli di fede, mentre la “vita eterna” è uno degli articoli da subito inseriti. Il motivo sta nel fatto che la “morte eterna” non appartiene al Vangelo, non è una lieta notizia della Rivelazione, ma è solo consequenziale al rifiuto della libertà umana di consegnarsi alla misericordia di Dio. L’esistenza dell’inferno non può essere negata, ma va correttamente compresa.
a. La dannazione dell’inferno non è simmetrica alla salvezza
Nel riflettere sull’inferno occorre partire dall’assioma centrale della fede, e cioè la predestinazione di ogni uomo alla salvezza in Cristo. Questo è il cuore del Vangelo e sta al primo posto nella gerarchia delle verità escatologiche. Di conseguenza la minaccia dell’inferno non è simmetricamente equiparabile alla salvezza offerta da Dio ad ogni uomo in Cristo. Tra inferno e paradiso, cioè, vi è un’asimmetria, poiché la buona notizia portata da Gesù è, prima di tutto e soprattutto, che tutti gli uomini sono “oggettivamente e primariamente” dentro all’orbita della salvezza, sebbene dotati della capacità di uscirne fuori. L’esistenza umana non è come posizionata su un bivio con una uguale possibilità di scegliere la salvezza o la dannazione. Da parte sua, Dio non destina nessuno alla condanna e all’infelicità eterne. Se l’uomo si sottrae all’influsso salvifico, lo fa usando la sua libertà contro la volontà di Dio. La salvezza è dunque un fatto: Gesù Cristo si è incarnato, è morto e risorto, per garantire la buona riuscita della storia della libertà di ogni uomo. Pertanto, la salvezza è un evento alla portata di tutti, mentre la dannazione è solo una possibilità basata sulla libertà umana di chi si rifiuta di accogliere la salvezza.
b. La possibilità dell’inferno è garanzia della libertà dell’uomo
Consequenziale a questo primo punto è l’affermazione che l’inferno va postulato per salvaguardare la libertà umana. Se uno venisse attratto a Cristo contro la sua volontà, senza la possibilità di non aderirvi, si toglierebbe dignità all’uomo riducendolo ad essere un manichino. Se si negasse l’inferno e si postulasse per l’uomo soltanto un esito di salvezza, non ci sarebbe più differenza tra l’impegnare se stessi per Dio o contro Dio, né ci sarebbe differenza tra il fare il bene e il fare il male, poiché in entrambi i casi si otterrebbe il medesimo risultato. L’inferno esiste allora, prima di tutto, perché la creatura ha la possibilità di chiudersi liberamente all’amore di Dio. E da parte di Dio, l’inferno esiste perché ama la libertà dell’uomo fino all’estremo, cioè fino ad accettare persino che la sua creatura lo rifiuti. L’amore di Dio, per sua struttura intrinseca, si autolimita di fronte alla libertà umana e non intende imporsi alle nostre libertà: se lo facesse contraddirebbe la sua natura di essere l’amore, poiché l’amore dettato da costrizione o da necessità è morto. Amore e libertà si postulano reciprocamente: solo chi è libero può amare e chi ama lascia libero l’amato. Lo ha cantato mirabilmente Charles Péguy in uno dei suoi poemi lirici:
“Questo è il mistero della libertà dell’uomo, dice Dio: se lo sostengo troppo non è più libero; se non lo sostengo abbastanza, cade. Se lo sostengo troppo, metto a rischio la sua libertà; se non lo sostengo abbastanza, metto a rischio la sua salvezza. Due beni in un certo senso quasi ugualmente preziosi, perché la sua salvezza ha un valore infinito. Ma cosa sarebbe una salvezza che non fosse libera? Io voglio – dice Dio – che questa salvezza l’uomo l’acquisti da sé. Lui stesso, l’uomo. Tale è il segreto, il mistero, il valore della libertà dell’uomo: io stesso, dice Dio, sono libero e ho creato l’uomo a mia immagine e somiglianza. E la libertà della creatura è il più bel riflesso di Me, che ci sia al mondo. Una salvezza che non fosse libera, che non venisse da un uomo libero che sarebbe mai? Che interesse presenterebbe? Una beatitudine da schiavi, una salvezza subìta, una felicità serva, che cosa volete che m’interessi. La mia potenza risplende abbastanza nelle sabbie del mare e nelle stelle del cielo: non è contestata, è nota, risplende abbastanza nella creazione inanimata. Ma nella mia creazione animata ho voluto di meglio, ho voluto di più. Infinitamente di meglio. Ho voluto la libertà. Ho creato questa libertà. Quando una volta si è provato ad essere amati liberamente, le sottomissioni non hanno più nessun gusto. Quando si è provato ad essere amati da uomini liberi, il prosternarsi degli schiavi non dice più nulla”.
Ecco, dunque, su che cosa si fonda la possibilità dell’inferno: sulla libertà dell’amore, che è l’essenza di Dio e, corrispettivamente, sulla libertà dell’uomo che è creato a sua immagine.
c. Non è sproporzionato un inferno eterno a colpe limitate della creatura?
Qui s’inserisce una obiezione contro “l’eternità dell’inferno”. Come può la giustizia di Dio dare una pena “per sempre” in punizione di peccati che, per quanto grandi e liberamente commessi, sono compiuti da persone limitate? Oltretutto l’uomo è condizionato dal male che lo circonda e dalla sua intrinseca debolezza: come può Dio, se è veramente giusto, essere così spietato da dannare per sempre un essere umano per colpe che, per quanto grandi, sono sempre compiute da un essere finito e condizionato? La pena non deve essere commisurata alla colpa?
- Questa obiezione si basa su un equivoco sottile, che sta nel fatto di considerare l’inferno come una “pena vendicativa”, comminata cioè dal tribunale di Dio con lo scopo di rendere giustizia a un danno commesso mediante una riparazione adeguata. In questo caso si dovrebbe giustamente rispettare il criterio di proporzionalità rispetto alla colpa. In realtà però la condanna non è una pena inflitta da qualche entità (Dio, il diavolo) che punisca la cattiva condotta dell’uomo. La condanna, al contrario, è interiore all’uomo stesso; è lui che, giorno dopo giorno, confeziona la sua condanna con il tessuto dell’egoismo, cioè, avvitandosi su se stesso in una chiusura che si rifiuta di concedersi all’amore di Dio: “Cristo non condanna nessuno alla perdizione – osserva J. Ratzinger -, egli è pura salvezza; e chi sta presso di lui, si trova entro lo spazio della liberazione e della grazia. … colui che è perduto ha tracciato da se medesimo il confine che lo separa dalla salvezza”. Il male non viene inflitto da Dio, ma esiste là dove l’uomo è rimasto lontano da lui; nasce dallo starsene chiusi nel proprio “io”. Oltretutto dalla Rivelazione divina sappiamo che Dio sa bene quanto è debole l’uomo: “Sa di che siamo plasmati, ricorda che noi siamo polvere” (Sal 103, 14); e che, mentre “l’uomo si ferma all’apparenza, Dio guarda il cuore”; ed ancora che “Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa” (1 Gv 3, 20). Non c’è da temere un giudizio punitivo e severo da parte di Dio. Semmai il giudizio di Dio è eccedente nella misericordia, con un amore che sa accogliere teneramente ogni peccatore che appena, anche di poco, si apra con fiducia alle sue braccia paterne (Lc 15).
- L’obiezione sull’incomparabilità di una pena eterna per il peccato umano si radica anche sul fatto che vi è una comprensione distorta dell’eternità. Questa viene pensata come un prolungamento “temporale senza fine”, cioè una temporalità interminabile. E’ chiaro che allora mettere sulla bilancia, da una parte, una colpa limitata e temporale e, dall’altra, una pena eterna che dura per sempre, pare una sproporzione non degna della giustizia di Dio. Il fatto però è che chi si danna è perché decide di opporsi a Dio, facendo dell’opposizione a Dio la sua scelta definitiva fino all’ultimo istante in cui è in grado di esercitare la sua libertà. Il concetto di “eternità” applicato alle realtà escatologiche, dunque, non va misurato sul tempo lineare della terra; esprime piuttosto la definitività in cui un essere libero decide di porsi: nel caso dell’inferno possiamo dire che consiste in una definitività di isolamento dall’amore di Dio e un’opposizione alla paternità misericordiosa di Dio. E se i dannati non possono più pentirsi una volta entrati nell’eterno, è perché “per i dannati non c’è più il tempo di pentirsi, perché sono usciti dal tempo e sono totalmente racchiusi nell’istante del loro rifiuto di Dio, cui non fa seguito nessun altro istante”.
d. Qual è la natura dell’inferno?
Se l’inferno è intrinsecamente connesso con la libera volontà dell’uomo, bisogna dedurne che esso è una tragica possibilità per l’uomo. E siccome la natura dell’inferno “è voler essere senza Dio”, non è Dio a creare l’inferno. Dio vuole solo il bene della creatura, mentre l’inferno è la sua negazione. Dio non vuole l’inferno, questo rifiuto tragico e definitivo dell’amore. Dio non ha fatto l’inferno. L’inferno lo fa l’uomo quando rifiuta totalmente l’amore di Dio. In che cosa consiste allora la natura dell’inferno. Gesù per spiegare la condizione di colui che si danna ha fatto ricorso soprattutto al concetto di esclusione. Nella parabola delle vergini: “La porta fu chiusa” (Mt 25, 10). Nella parabola dei talenti, al servo che non ha fatto fruttare il talento per paura dice: “Gettatelo fuori”. Nel giudizio alla fine della storia: “Via, lontano da me maledetti” (Mt 25, 41). Nella parabola della zizzania: “Estirpate prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla” (13, 30). Paolo dà una versione sportiva dello stesso concetto, ricorrendo all’immagine della squalifica dal gioco della vita: “perché non succeda che, dopo avere predicato agli altri, io stesso venga squalificato” (1 Cor 9, 27), cioè estromesso dal partecipare alla vita d’amore. Seguendo il filo di queste immagini possiamo affermare che l’inferno è l’autoesclusione libera di fare propria la relazione d’amore con il Dio Unitrino, che ci è stato rivelato in Gesù. Gesù conosce fino in fondo il cuore umano. Egli sa che è fatto per la felicità e che la felicità sgorga da un rapporto riuscito con l’Eterna Comunione divina e con tutte le creature uscite dalla sua mano. Negarsi alla comunione con Dio e con gli altri è la natura profonda dell’inferno. Chi ha scelto se stesso, alla fine ottiene solo se stesso.
e. Come può uno dannarsi se non ha mai conosciuto Dio?
Se l’inferno è negazione di Dio in forza di una decisione libera, come possono salvarsi coloro che non hanno conosciuto Dio o ne hanno conosciuto una delle tante deformazioni idolatriche di cui è pieno il mondo? Può il Dio di Gesù Cristo, che è misericordia infinita, abbandonare all’inferno chi non avesse avuto modo di conoscerlo e, di conseguenza, di non poterlo nemmeno rifiutare in maniera libera e consapevole? Nel NT è descritto un altro modo per rifiutare Dio e consiste nel rifiuto del fratello, che è immagine di Dio. I dannati del brano di Mt 25 sono sorpresi di vedersi accusati di non aver soccorso il Signore (“Signore, quando ti abbiamo visto affamato o assetato …?); e la risposta è: “Ogni volta che non avete fatto queste cose a uno dei miei fratelli più piccoli, non l’avete fatto a me. E questi se ne andranno al supplizio eterno”. Ecco dunque la risposta all’interrogativo. La sorte dell’uomo non si decide solo in una opzione esplicita di Dio, in cui cioè si possa nella fede riconoscere e aderire apertamente a Dio che si è rivelato in Gesù. Si decide anche di fronte a colui che, oggettivamente, è l’immagine di Dio e sacramento di Cristo, cioè mediante l’esercizio della carità verso il prossimo. La cura del prossimo è scritta nella struttura intrinseca dell’uomo: è la legge conoscibile da chiunque si osservi nella sua umanità. Perciò nessuno è escluso dalla possibilità di salvarsi, se pratica la giustizia della carità verso il fratello. Esiste pertanto una via alla portata di tutti gli uomini per raggiungere la salvezza ed è il più umano degli atteggiamenti, qual è quello di stare compassionevolmente (patire insieme) di fronte a un essere che abbia bisogno. Il motivo teologico è che il Cristo si è identificato con il più povero degli uomini: e oggettivamente, al di là di ciò di cui una persona possa soggettivamente essere cosciente, servire il povero è vivere la carità del Cristo e portare in sé un riflesso della Carità divina che vive nel mistero trinitario. Questo apre la via alla salvezza.
f. La posizione del cristiano: “sperare per tutti”
Agli inizi degli anni Ottanta, H. U. von Balthasar espresse la speranza che nessuna persona raggiungesse la condizione dell’inferno. Questa speranza fu volgarizzata dai giornali con la formula: L’inferno esiste, ma è vuoto. Evidentemente è una riduzione ambigua. Che cosa intendeva dire Balthasar? La realtà è che “nessuno può dire che non c’è l’Inferno o che nessuno vi si trova. Uno (Gesù disceso agli inferi) vi è entrato sicuramente e più profondamente di quanto sia possibile a nessun altro”. Balthasar, criticando la linea agostiniana della “massa dannata”, recupera dalla Tradizione una linea escatologica minoritaria, ma ben rappresentata che, da Origene in poi, mette in evidenza la superiorità della salvezza sulla condanna e, quindi, la possibilità di sperare per tutti. Sempre Balthasar alla fine della vita, in un’intervista, ebbe a manifestare che anche alcuni amici si sono mostrati perplessi riguardo al suo pensiero su questo tema:
“Dovrebbero capire – dice loro – … che io non voglio sapere qualcosa di più di quello che insegna la Scrittura; che io non pretendo di sapere nulla “prima” del giudizio di Dio; che io non sono certo di niente di quello che appartiene solo al segreto di Dio. Io voglio solo poter sperare, avere il diritto di sperare, voglio che sia lecito “sperare per tutti”. Sono gli altri che vogliono essere certi! Certi che ci siano dei dannati, certi che l’inferno sia pieno, certi che Dio non possa salvare tutti. Se io pretendessi di essere certo dell’esito dell’ultimo giudizio di Dio sarei eretico, ma io voglio solo poter sperare, poter pregare per la salvezza di tutti, ritenendo possibile che Dio esaudisca le nostre preghiere”.
L’inferno dunque esiste, ma non sappiamo se qualche essere raggiunga la situazione di totale chiusura alla grazia. Se non esistesse questa drammatica possibilità, la libertà umana sarebbe una parola vuota.
padre Antonello Erminio